Una flessibilità del lavoro femminista?
di Maria Grazia Campari
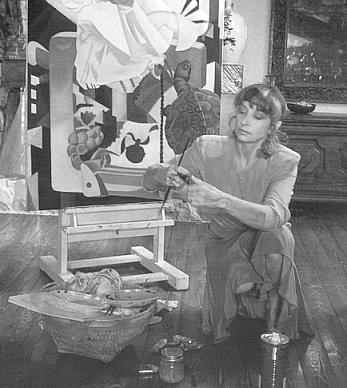
l'artista Wanda Broggi al lavoro
Una quarantennale esperienza di avvocata del lavoro mi ha messo in contatto da quindici anni con casi di prestazioni di lavoro fortemente improntate alla flessibilità, introdotta a partire dai secondi anni novanta (leggi Treu, Biagi-Maroni, ecc.). Posso ben dire che, attraverso le mie clienti, la flessibilità me ne ha fatte vedere di tutti i colori.
Esemplifico. Nella cintura milanese, industrie chimiche di media grandezza, occupavano un nucleo stabile di lavoratori regolarmente a contratto e circa il triplo di lavoratrici flessibili, «a chiamata», per interposte cooperative, anche per turni domenicali e notturni, retribuite «in nero» dalle cooperative. Solo le più docili ottenevano qualche contratto a termine dall’azienda che, dopo pochi mesi di lavoro «regolare», le ripassava alla cooperativa, pur continuando esse a fare lo stesso lavoro nella stessa fabbrica.
Al centro di Milano, notissime società di sondaggi telefonici o telemarketing impiegavano intervistatrici retribuite a ritenuta d’acconto, ingaggiate «a chiamata», con turni, orari, livelli di produttività rigidi, simili al cottimo d’altri tempi.
Altre volte è capitato che giovani guidatrici con automezzo proprio venissero spedite da imprenditori pubblicitari in Lombardia o Piemonte per reclamizzare catene di negozi e grandi magazzini, con promessa di retribuzione a giornata, poi negata col pretesto che l’attività da loro
svolta era ritenuta dall’imprenditore insufficiente.
Conseguenza: tempo e costi di lavoro diventavano una donazione forzata delle più povere ai più ricchi.
Fino al caso di un importante corriere internazionale che per la consegna di plichi e merci in Milano subappalta il servizio a un «padroncino» di automezzi. Questi, a sua volta, ingaggia una coppia di addetti per ogni furgone, i quali provvedono alla consegna dei pacchi. O meglio, il «padroncino» subappalta il lavoro a un autista che retribuisce a fattura come lavoratore autonomo, che spesso utilizza come secondo autista e portatore della merce dal furgone al recapito, la sua compagna,
da lui stesso retribuita «in nero».
La donna non riceve un compenso proprio, ma una parte del compenso altrui, e non è titolare di nessun contratto.
Questa esperienza professionale ha destato il mio interesse per due scritti della Libreria delle donne di Milano nel Sottosopra «Immagina che il lavoro» e nel «Quaderno» di Via Dogana, «Lavoro e
maternità. Il doppio sì».
Il più recente, «un manifesto del lavoro delle donne» in dieci punti, esordisce con un indirizzo alle lettrici: «oggi non trovi una sola donna che si senta categoria debole...nell’eterno gioco di rincorsa alla parità» e prosegue : «...voglio dire la mia sul lavoro, sull’ambiente, sull’economia, sul futuro. Sulla politica meno: è già stato detto molto e non vedo molta disponibilità ad ascoltare. Anzi a me la politica par di farla solo quando riusciamo a dar parole pubbliche ai nostri punti di vista».
Apprezzo l’invito a non ripiegare sull’autocommiserazione, purché, però, ci si intenda sulle modalità (anche conflittuali) mediante le quali porre riparo a situazioni spesso assai deteriori che riguardano ancora le lavoratrici dell’Europa mediterranea (dati Eurostat).
Una via è quella, indicata, di farsene carico prendendo la parola pubblica sui temi evidenziati. Ma perché contrapporre il desiderio di occuparsi di argomenti rilevanti, quali ambiente, economia, lavoro, e la contrarietà a occuparsi di «politica»?
Lo spazio pubblico è, in una democrazia partecipata, spazio della parola che mette in comunicazione i cittadini; confronto incessante e scambio (anche conflittuale) che registrano una comune responsabilità nella sfera pubblica. Questa è politica.
Forse con «politica» lo scritto intende riferirsi allo stato attuale della cosa pubblica cui si accede grazie al benvolere di oligarchi, professionisti nell’occupare tutte le strutture, anche istituzionali, o attraverso cooptazioni o fittizie competizioni elettorali. Occorre allora esplicitarlo e legarlo
alla critica del presente perché, se no, si rischia di offuscare la possibilità di qualsiasi azione per cambiare le cose. Come estraniarsi dallo stato della politica se si vuole incidere con parola
pubblica nello spazio pubblico?
Quanto al lavoro, il manifesto giustamente ribadisce che, come le economiste femministe
insegnano, nei rapporti di produzione i soggetti sono donne e uomini, e si intrecciano condizioni di vita e di lavoro. Dimentica però i conflitti che questi producono nella struttura stessa del mercato del lavoro.
Anzi, sostiene un felice innesto nell’attività lavorativa del sapere femminile sulla quotidianità: «un lavoro imprenditivo e creativo» che «non si vede nel Pil, non si vede nella busta paga, non si vede
negli indicatori di benessere delle nazioni e degli individui».
L’assenza di compenso per questi apporti preziosi viene pacificamente constatata; si sottolinea anzi che c’è una «parola magica per rimuovere il conflitto: conciliazione tra i due lavori (produttivo e riproduttivo) per entrambi i sessi». Nella realtà - si ammette - ciò non si verifica, ma le donne decidono lo stesso: «Scegliamo tutto. Il piacere di stare con i figli e di lavorare bene. Il doppio sì».
Questo è il fulcro del discorso.
Si tratta del part time conciliativo che consente la doppia scelta del lavoro e della maternità, concetto in cui è inserito,ma sottaciuto, il lavoro riproduttivo domestico e di cura, e si enfatizzano
le funzioni femminili, prolungandone l’efficacia (gratuita) nella prestazione lavorativa - capacità
relazionale-gestionale non prevista nella retribuzione.
Nel vantato favore femminile per questo tipo di rapporto è assente qualsiasi lettura della realtà: da quale posizione sociale e da quale reddito si parla? Con quali conseguenze sul benessere o sulla povertà femminile e minorile nei casi di separazione e divorzio? Con quali riflessi sull’entità delle pensioni?
Anche l’elogio del lavoro di cura come modalità di ampliamento delle conoscenze rimanda a
un concetto ambiguo, vero ma forzato dalla limitazione dello sguardo sul mondo.
L’ampliamento di conoscenze, oltre che nel lavoro riproduttivo e nelle relazioni di cura, si può conseguire attraverso il confronto fra culture (incontri, letture, formazione plurilingue, approfondimenti teorici, relazioni professionali multidisciplinari), mentre le capacità gestionali
si possono valorizzare attraverso lavori professionali di organizzazione delle risorse, e come tali retribuiti, non erogati gratuitamente.
Si sa che l’articolazione dell’attività femminile fra lavoro formale per il mercato e informale per la famiglia, avviene perlopiù a scapito delle conoscenze, e anche della formazione continua ormai richiesta per gli impieghi qualificati e ben retribuiti. L’esperienza mi dice che la valorizzazione
delle doti femminili come leva per una flessibilità contrattata riguarda settori molto ridotti di occupazioni specialistiche e non permette di formulare regole generali.
La scelta del «doppio sì», che si verifica per esigenze varie, anche economiche, pur senza condivisione dei compiti in famiglia, potrebbe essere interrogata come conveniente perché a-conflittuale. La mancanza di recriminazioni femminili intrafamigliari per scelte che penalizzano
la donna sul lavoro (blocco o regressione di carriera per cura dei figli), si può spiegare con il «desiderio adattativo» (scelgo ciò che la cultura dominante mi indica) utile per evitare il conflitto coniugale, ma tale desiderio può regredire dove una cultura (sindacale) autorizza il conflitto.
Inoltre, chi enfatizza la positività del «doppio sì» non esamina il futuro di chi si carica della doppia presenza: basso reddito professionale, che crea nuove povertà per madri e figli minori, accorciamento della carriera lavorativa dunque pensioni insufficienti in età avanzata. Mi pare alquanto fantasticata la figura femminile forte delineata dal termine «donna realista ed elastica»: a uno sguardo attento essa appare più adattativa all’esistente che consapevole del proprio futuro.
Purtroppo questa impostazione trova consonanze in parlamento. Il disegno di legge (Ddl 784/09) presentato dal Partito democratico nel gennaio 2009, «Misure per favorire l’occupazione femminile e la condivisione e conciliazione fra cura e lavoro» non scalfirà neppure la situazione attuale, la conciliazione fra lavoro produttivo e riproduttivo venendo messa a carico delle sole donne. Basti dire che è prevista una detrazione fiscale per le lavoratrici madri a basso reddito di soli quattrocento
euro all’anno per il primo figlio, la estensione del part time alle dipendenti del settore privato e l’elargizione a favore dei padri di soli dieci giorni di assenza - retribuiti al cinquanta per cento - per la cura dei figli neonati.
Queste relazioni dispari fra i sessi, che determinano la precarietà economica delle donne, hanno precise ricadute sui diritti di cittadinanza: sono esse a produrre l’estraneità delle donne alla sfera pubblica, concorrendo alla scarsa qualità del nostro assetto democratico.
da il manifesto del 6 novembre 2009