Le donne di Cavalese
di Vittorio de Savorgnani
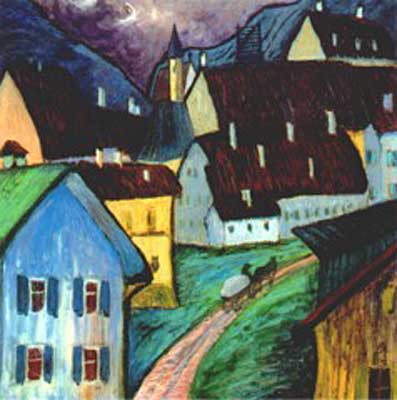
Marianne von
Werefkin
Abito ai piedi della
famosa Foresta del Cansiglio, a cavallo tra Veneto e Friuli, che ormai da
22 anni è diventata anche il luogo del mio lavoro. Ma per me il Cansiglio
è molto di più. I miei nonni materni erano cimbri (comunità proveniente
dall’altipiano di Asiago alla fine del ‘700 e, prima ancora, dalla
Baviera); da loro ho assorbito, fin da bambino, l’idea del bosco come un
luogo importante, vivo, pieno di presenze, fonte di vita e lavoro ma anche
pericoloso e misterioso. Una visione primitiva ed emotiva ma che, anche
attraverso il timore per ciò che è sconosciuto, non poteva che generare
rispetto. Del resto la paura per la foresta fa parte della nostra memoria
ancestrale e la prova di questo antico sentire la possiamo trovare in
alcune parole che usiamo comunemente, pur senza la coscienza della loro
origine: selvatico o
selvaggio è ciò che proviene dalle
selve, mentre chi non fa parte della nostra comunità e viene da un altro
luogo, anche se questo è un termine d’uso dialettale, è definito come
foresto, dunque sempre la foresta
di mezzo.
Nel 2004 ho compiuto
mezzo secolo di vita e circa 5 anni fa ho capito che questo mio bagaglio
di conoscenze, acquisito per lo più inconsapevolmente, attraverso i nonni,
i boscaioli, i pastori dell’altopiano del Cansiglio, andava fissato in
qualche modo. Ricordavo storie e racconti sentiti da un mucchio di gente,
per lo più anziani, che se n’erano andati senza lasciare traccia alcuna.
Così ho incominciato a scrivere, senza alcuna pretesa di ricerca
antropologica, ma solo per amore e rispetto di quelle generazioni che ci
hanno preceduto, affrontando esperienze di vita dure ma anche, molto
spesso, avventurose e affascinanti. Una dimensione che abbiamo perso
quasi del tutto, ossessionati, anche giustamente, dal bisogno di garanzie
e sicurezze.
Dopo un anno di notti
trascorse a scrivere e correggere, ne è uscito un libro che ho intitolato
Cansiglio nostra Signora, pubblicato
tre anni fa, nel quale non solo ho riportato le leggende e le storie
raccolte, ma ho inserito anche esperienze personali e l’interpretazione di
eventi attuali. E qui vengo al perché di questo mio intervento. Mentre
stavo raccogliendo materiale per il libro, era ancora viva e dolorosa la
memoria dell’incidente del Cermis, avvenuto il 3 febbraio del 1998, quando
un aereo militare americano, di una pattuglia in volo di addestramento,
tranciò la fune della cabinovia provocando 20 morti.
Ma quella squadriglia
era partita dalla base USA di Aviano (Pordenone), proprio sotto la Foresta
del Cansiglio… Così mi sono interessato alla funivia del Cermis, al suo
tragico record di incidenti, visto che il 9 marzo del 1976 una sua cabina
era precipitata provocando 42 morti. Raccogliendo articoli dalla stampa
sono venuto a conoscenza della leggenda della “maledizione del Cermis” che
sarebbe stata pronunciata da 15 donne della Val di Fiemme, accusate di
stregoneria, arrestate, torturate, condannate e poi bruciate tra il 14
gennaio ed il 20 aprile del 1505. Ho ritrovato tutta la loro tragica
storia in Processo per magia di M.
Antonietta Serena e Nino Berruti, da cui si capisce come delle semplici
donne siano diventate “streghe” perché in quel periodo in ogni luogo, in
ogni valle, ci dovevano essere degli esempi drammatici ed intimidatori per
riportare il popolo sulla “retta via”. Dieci donne bruciate, cinque morte
sotto tortura, ma in un periodo in cui, in tutta l’Europa, i processi
dell’inquisizione si contarono a decine di migliaia e a centinaia di
migliaia i morti.
Ma ho anche scoperto
che, da qualche anno, questo tragico evento era rinnovato con una specie
di rievocazione teatrale, nei primi giorni dell’anno ed ho voluto
assistervi venendo a Cavalese sia nel 2002 che nel 2003. La prima
volta sono rimasto molto coinvolto dalla rievocazione, complice
l’ambientazione notturna, la partecipazione emotiva degli attori e la
drammaticità degli eventi. Invece la seconda volta tutto mi è apparso
sotto una luce diversa ed ho provato fastidio ed un senso di ribellione:
si stava ricordando un evento luttuoso che aveva provocato dolore e morte
ed uno strascico di terrore durato per secoli, ma lo si stava riproponendo
in modo folcloristico e strumentale, con lo spirito della sagra di paese
organizzata nel periodo di maggior presenza turistica. Era evidente che la
scelta del periodo era funzionale a far rientrare l’evento nella lista
degli intrattenimenti mondani per i turisti dello sci invernale, nel
periodo delle ferie natalizie. Sarebbe come organizzare la rievocazione
della tragedia del Vajont come uno spettacolo per i turisti estivi… I
fatti di Cavalese non sono recenti come il crollo della diga bellunese,
sono passati 5 secoli, ma sempre di morti si tratta e soprattutto a quelle
vittime innocenti non è stata ancora resa giustizia.
Per questo mi è
sembrato ipocrita ed ingiusto sentire, per due volte, il commentatore
fuori campo ripetere “..noi non giudichiamo la storia..”. Ma come è
possibile? Sarebbe come leggere Il diario di Anna Franck e poi
rifiutarsi di giudicare…
E’ mia opinione che gli
abitanti di Cavalese dovrebbero rifiutarsi di trasformare una pagina
dolorosa della loro storia in un richiamo turistico o, almeno, avere il
coraggio di riconoscere che quelle donne sono state delle vittime
innocenti. O si ritiene che questo possa “disturbare” i turisti togliendo
truculenza alla narrazione e dando alla rievocazione un taglio troppo
“politico”? Troppo comodo e da opportunisti nascondersi dietro
l’imparzialità storica in nome dell’industria turistica!
Il mio augurio è che si
formi un gruppo di abitanti di Cavalese desiderosi di capire quello che è
veramente accaduto nella loro valle e desiderosi di rendere giustizia,
anche dopo secoli: lo stesso Santo Padre, Giovanni Paolo II, ha avuto il
coraggio di chiedere pubblicamente scusa per le violenze e gli omicidi
dell’inquisizione, possibile che a Cavalese non si senta il bisogno di
riabilitare quelle vittime innocenti?
Innanzitutto bisognerebbe smetterla di
definirle streghe e, caso mai, definirle “le donne di Cavalese” e
bisognerebbe, è mia opinione, dedicare loro una festa di riabilitazione e
riconciliazione, in primavera o in estate, per e tra gli abitanti della
Val di Fiemme.
Nella rievocazione
invernale, sotto l’esile crosta dell’evento turistico, sembra di sentire
ancora la nera energia dell’inquisizione: ma come si fa a divertirsi a
sentire le urla strazianti delle donne quando viene pronunciata la
condanna, al Banco della Rason? Come si fa a non sentire lo strazio, anche
se di finzione si tratta, quando si levano alte nella notte le fiamme dei
roghi?
Vien quasi da pensare
che se dopo cinque secoli il ricordo del processo è ancora così vivo in
valle, forse la comunità fiemmazza prova ancora, anche se non lo vuol
riconoscere, una qualche forma di rimorso su cui farebbe bene a ripensare
e sarebbe una prova di grande umiltà, intelligenza e sensibilità umana e
storica.
15/02/2005
|