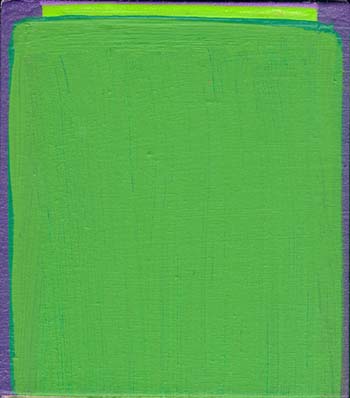Intorno
a un cerchio
Una riflessione sui corsi dell 'Università delle donne
con il gruppo di Cernusco
di
Donatella Bassanesi
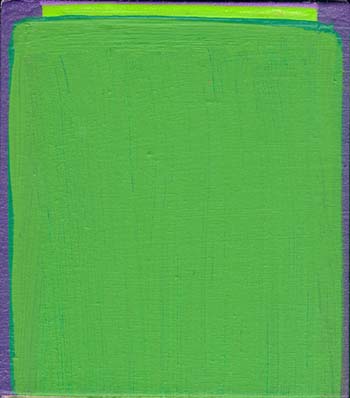
Maria Morganti
…e pescare nel cerchio
dove volano e si versano i pensieri pensati
e le sensazioni percepite in quel cerchio in mezzo al quale
spira una dolce aria di voglia di crescere e dove fluttua
tutto ciò che non siamo ancora in grado di fermare.
Ilaria Dello Strologo
Noi usiamo il registratore, vorremmo riprodurre comunicare cosa avviene
nei nostri corsi. Ma la registrazione non rende cosa avviene qui dentro.
La trascrizione appiattisce. "La registrazione esatta di una
conversazione che era sembrata brillante dà poi un'impressione
di povertà: manca infatti la presenza degli interlocutori, mancano
i gesti, le fisionomie, il sentimento di qualcosa che sta per sopraggiungere,
di una continua improvvisazione. Oramai la conversazione non esiste
più: essa è, livellata" M. Merleau-Ponty, Segni,
Milano, 1967, p. 84).
Ci sono
momenti alti, intuizioni da cui diversamente ciascuna è colpita,
immagini. A volte, l'effetto è trascinante. Prende forma tra
di noi come un segreto. Sono momenti irriproducibili. Possiamo dire
che noi qui commentiamo. E "Il commento proietta lo spirito
in tutte le direzioni, evoca un passato cospicuo, concentra una massa
imponente di sogni e di paura" (G. Bachelard, Psicanalisi dell'aria,
Como, 1988, p. 98).
Ripensare
a quel che è avvenuto, scriverci attorno allunga questo tempo,
lo modifica, lo svela, lo mostra come possibilità. Sono riflessi
che ci spostano verso il futuro, producono qualcosa che ci chiede di
intervenire, ci interroga. E l'interrogazione va oltre la richiesta
di spiegazione. Non si tratta semplicemente di spiegare, un aprire ciò
che è chiuso (un togliere le pieghe). È piuttosto una
domanda di chiarificazione, come un illuminare spazi-luoghi diversi
che intervengono mutando la prospettiva, alterano l'impianto fissato,
insistono evidenziando punti nodali che tornano ripetutamente fino a
diventare parole-chiave, strumenti interpretativi di un discorso che,
insieme, si va facendo. Ciò che avviene, che è avvenuto
è per ognuna diversamente. Mai veramente si compie, piuttosto
tende al compimento. Qualcosa passa inosservata.
Qualcosa ha avuto per noi importanza, si è impressa, pesa, ci
inquieta, torna e ci interroga. Occupa dell'altro tempo. Va oltre il
tempo. Il tempo così si dilata, non è il tempo dell'orologio
uniformemente uguale, scorre diversamente per ognuna. E c'è dell'altro.
I ritorni, insistenze intorno a, nel momento in cui vengono comunicati
diventano patrimonio comune, di tutte. Mostrano a tutte qualcosa. In
quanto ri-velazioni indicano qualcosa, che tuttavia torna sempre a velarsi
- lascia aperta la domanda, dà nuovo senso all'interrogazione:
così la domanda viene sempre come seconda, rimane aperta, non
richiede risposta. Questo insistere corrisponde a un pensiero che viene
formandosi collettivamente. E insieme, per ognuna uno spazio-tempo,
un luogo quantitativamente e qualitativamente diverso.
Un lavoro
che è un intreccio, nel quale l'impianto teorico è sostenuto
da voci, un contro-canto, non marginale. Perché sono le singole
ragioni, ragionamenti, pensieri che sostengono le proprie ragioni. Momenti
che sono i motori: allargano spazio e tempo. Fanno emergere figure non-tranquillizzanti
e definite.
Sono voci narranti che s-velano e ri-velano. È un narrare (comunque
imperfetto, approssimativo ma significativo) di quello che è
avvenuto e avviene tra di noi, un'intuizione di cui più tardi,
riflettendo, riusciamo a capire la portata. Si tratta di un ri-pensare
come un ri-percorrere e un ri-scrivere leggendo tra le righe. C'è
tra di noi un tra le righe che sta nel soggetto. Per ognuna ri-ragionare,
di ognuna con una diversa esperienza. Non si tratta di giudicare, ma
di segnalare. Riuscendo a seguire ogni percorso soggettivo vedremmo
come si intrecciano i fili (come noi costituiamo i fili di un intreccio).
Il gruppo agisce come un discorso collettivo, parola in comune. Il gruppo
così dice se stesso, è io narrante, agente, azione. Nel
parlare-agire il gruppo diventa creatore-creatura, nasce, si fa esistente.
La domanda
che ci poniamo a questo punto è: come può il gruppo
manifestare la sua esistenza al di là di se stesso?
Il gruppo può mostrarsi fuori (che è poi vedersi dal
di fuori)?
Il gruppo può descriversi. Ma solo attraverso le descrizioni
(i racconti, le riflessioni) di singole.
Cosa vuole dire riflettere attraverso la scrittura?
Prima di tutto la scrivente è una. Dominante sarà perciò
la sua soggettività. E tuttavia quella soggettività sta
all'interno di un farsi a più, cioè di un molteplice.
Inoltre scrivere è un modo di tornare sulle cose, un pensare
interrogante, quello che più si interroga, perché lo scritto
è qualcosa di altro da sé che ti osserva in qualche modo
dal di fuori. Si tratta di un vedersi dal di fuori, un'attitudine a
giudicarsi piuttosto che giudicare qualcosa che sta al di fuori di sé.
Lo scritto che è perciò altro da sé ma che parte
da sé, che porta a un continuo sdoppiamento (e anche una scoperta,
una parte di sé che non riconosce l'altra). Qualcosa cambia.
Ma con il passaggio dall'esperienza alla riflessione sull'esperienza
- dall'ordine degli eventi a quello dell'espressione - non si cambia
mondo.
Scrive Merleau-Ponty: "I medesimi dati che prima erano subiti
divengono ora sistemi significanti. Scavati, lavorati dall'interno,
liberi infine dal peso che ce li rendeva dolorosi o ci feriva, divenuti
trasparenti o perfino luminosi, e capaci di rischiarare non solo gli
aspetti del mondo che somigliano loro, ma anche gli altri, essi continuano
a essere presenti nonostante la loro metamorfosi" (M. Merleau-Ponty,
Segni, Milano, 1967).
Franca:
Non è qualcosa di simile alla psicoanalisi?
Donatella: In un certo senso. Ma nella psicoanalisi c'è un referente
esterno che è lo psicoanalista.
Ilaria: Potrebbe essere anche pericoloso, risvegliare qualcosa che poi
non potremmo gestire.
Donatella: Ma no…tenete presente che il nostro obbiettivo primo
è che ciò che avviene tra di noi non sparisca. E d'altra
parte il lavoro di ripensamento è necessario in qualsiasi forma
espressiva: ogni forma espressiva è un pensare e un ripensare.
Non c'è interprete ultima.
E si potrebbe anche dire che ognuna, nel momento in cui scrive (più
ancora di quando parla), si assume una responsabilità verso il
gruppo, lo interpreta attivamente (non gli si affida passivamente),
agisce (ogni forma di pensiero è azione, per Hanna Arendt).
Così un percorso conoscitivo si tende verso lo svelamento: di
ciò che non si sapeva prima, che ora ti pare di intravedere.
Perché ciò che non conosci sta oltre il limite.
E il limite disegna un oltre, un possibile.
Mi dispiace che oggi non ci sia Giuliana. Lei più volte è
tornata sulla questione del limite.
Se tu non segni un limite stai nell'indefinito, nell'imprecisato. E
come se tu non mettessi a fuoco. Lo stesso pensiero di infinito è
in relazione con il limite, cioè col finito.
Una zona d'ombra segna il limite. Contemporaneamente indica qualcosa
che ci riporta all'interno (verso il centro del cerchio che noi complessivamente
costituiamo, e verso il nostro personale centro), e segnala la presenza
di qualcosa che sta fuori, che abbiamo dietro le spalle, percepiamo
come un riflesso ed è il nostro futuro (il futuro che ci sta
alle spalle e che perciò non vediamo).
Dina: Io
vorrei osservare come noi ci mettiamo in cerchio dal tempo dell'autocoscienza.
Possiamo fare una relazione tra prima e adesso? Vorrei capire cosa vuole
dire adesso (adesso quando, forse, una certa ricerca degli agi ci ha
fatto dimenticare le cose concrete). Il cerchio è lo stesso,
però a me pare che cambiano i tempi, gli argomenti, i ragionamenti.
Donatella: È vero noi abbiamo costruito uno spazio di rapporto
che è circolare. Una linea che delimita quello che sta dentro
e quello che sta fuori (come spazio delimitato è dotato di forza
centripeta, ma come centro irraggiante è dotato di forza centrifuga).
Si più pensare così la linea del cerchio come luogo di
incontro (o punto di equilibrio) tra un movimento (o tempo) rivolto
all'interno e un movimento (o tempo) rivolto all'esterno. Un trapassare
tra essere e non-essere.
D'altra parte noi riflettiamo il tempo in cui siamo. Siamo riflesso
del presente: interroganti-interrogate.
Se dovessimo definire il nostro pensiero oggi, si potrebbe dire che
è meno semplificato rispetto ai nostri inizi. Allora, come uscite
da una sorta di mutismo antico, tutte tese a raccontarci, cercavamo
identificazioni, approvazioni. Adesso siamo più in una condizione
di ascolto, sono meno frequenti le identificazioni (in positivo o in
negativo), è un pensare che va oltre il nostro affanno quotidiano.
Dina: Possiamo permetterci questo. È un lusso. Questo che si
fa serve a noi, non serve ad altre donne.
Donatella: È un privilegio ma anche un impegno (verso le altre),
affinché uno spazio-tempo di riflessione possa chiamarsi una
conquista (per tutte).
Ilaria: È una crescita.
Donatella: L'impegno di tutte (a riflettere, a tornare sulle questioni
che emergono, a lasciare una traccia pubblicando una dispensa…)
fruttifica. Così si allarga il cerchio (e cresce l'albero).
Non basta perciò sentire di aver fatto una cosa interessante.
Così serve solo a noi - ma poi non serve neanche a noi perché
se il cerchio non si amplia ci sentiamo in colpa verso le altre, quelle
che non possono…
Direi che l'autocoscienza è stata una pratica che ha cambiato
qualcosa complessivamente. È stata molto generalizzata. Non portava
firma, non c'era un'autrice a cui riferirsi. Senza-madre e anonima,
è stata un modo di porsi, di farsi interrogare e di interrogare
quel momento. Le singole vite ne sono rimaste scosse, i ruoli sono stati
sottoposti a revisione critica. L'autocoscienza ha certamente prodotto
una tensione ad-tenzione critica verso noi stesse, verso le questioni
legate al potere.
Oggi per noi si tratta di percorrere quel doppio movimento che è
necessario ad ogni iniziare. Distanziarsi da e andare verso.
La domanda
che potremmo porci è: cosa corre tra di noi?
Formalmente c'è una maestra, ci sono delle corsiste.
Ornella, tu l'anno scorso avevi raccontato di essere arrivata a scuola
con un vestito rosso e che la preside incrociandoti ti aveva detto:
"come stai bene vestita di rosso!…" e tu non ti
sei più vestita di rosso a scuola, perché, dicevi, devono
emergere gli studenti, l'insegnante non deve primeggiare.
La maestra tradizionalmente si mette davanti come a tirare il gruppo,
di lei il gruppo vede le spalle, lei il gruppo non lo vede.
Se io mi penso come maestra mi vedo dietro di voi. Mettendomi dietro
penso di poter vedere dove il gruppo va, posso cercare di tenerlo insieme.
Questo significa anche uscire dal tracciato in precedenza fissato, non
mettersi nella posizione di chi vuole convincere della giustezza di
quel che va dicendo. Senza la rete di un tracciato a cui attenersi può
capitare di sentirsi spiazzate, generalmente porta qualcosa di nuovo,
qualcosa nasce.
Ma per vedersi in faccia bisogna mettersi contro, anche eventualmente
contrastare, bisogna avere dei momenti a tu per tu.
Ornella: Io dico che il rapporto col maestro è un rapporto problematico.
E con ogni persona (ognuno di noi è maestro) può esserci
un rapporto di questo genere. Quando ci si pone l'obbiettivo di superare
il maestro si può rimanerne schiacciati, o esaltati. Preferirei
piuttosto: prendere dall'altra persona, non tanto contrapporsi, fare
tesoro di quello che hai preso.
Donatella: Ma mettersi contro significa prima di tutto vedere la faccia
dell'altro, riconoscerla come diversa, è vedersi reciprocamente.
Io adesso con te sono di fronte, cioè contro, non necessariamente
mi oppongo e facciamo la rissa.
Rosanna: posso osare mettermi di fronte. Può essere un contro
che non è uno s-contro e in-contro.
Maria: Qui noi abbiamo lo spazio di una settimana in cui continuiamo
a pensarci e ripensarci, uno spazio nostro per riflettere. Tu puoi solo
dare degli stimoli. Il confronto ci porta a superare noi stesse (e anche
il maestro-la maestra). Avendo un confronto fra tutte avviene qualcosa
di diverso, di più.
Donatella: Sì quello del ripensamento è un margine di
libertà, è vedersi in un mutamento possibile
Rosaura: Che ci sia scontro o no, credo importante ci sia una verità
di emozione. È guardarsi in faccia, è ascoltare. Allora
scopriamo che la ricchezza non sono le certezze ma l'incontro e lo scontro
e la voglia di crescere come ha scritto Ilaria. E la voglia di crescere
è una cosa che mi dà una gioia…
|