CONFITEOR
?
O ALTRO PIOMBO SUGLI ANNI SETTANTA?
di Maria Schiavo
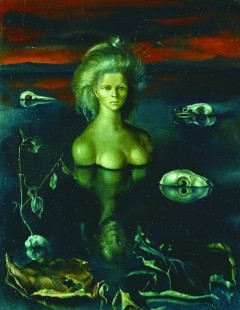
Leonor Fini
La secolarizzazione dell' uso della confessione come contrizione ha aspetti inquietanti. Il tentativo di creare oggi conciliazione fra le parti politiche avverse nei lontani anni Settanta, attraverso la pubblica ammissione delle proprie colpe, ricorda cose, atmosfere che concilianti non sono. Riecheggia, sotto l'apparente bonomia della proposta fatta da Pierluigi Battista, cose lontane che con la bonomia hanno poco a che fare: la caccia allle streghe, i processi della Controriforma, e più vicine a noi, le epurazioni comuniste, il maccartismo negli Stati Uniti degli anni Cinquanta. E il legame di coercizione, che corre tra queste pratiche che l'Occidente ha adottato non può non far tornare alla memoria quanto Michel Foucault dice della confessione come volontà di sapere delle istituzioni, strumento sociale di controllo dell'individuo, del suo passaggio (e quindi del suo nuovo uso politico), soprattutto a partire dal XIX° secolo, dal regime della colpa religiosa, morale, giudiziaria, a quello del normale e del patologico.
Infatti che cosa si chiede, nella proposta di Battista, ai facenti parte
dei gruppi extraparlamentari dell'estrema destra e dell'estrema sinistra
degli anni Settanta? Di dichiarare pubblicamente le proprie colpe. Di
rendere così possibile un ritorno alla normalità, uscendo
dalla storia di quegli anni e consegnandosi purificati a un presente che
non ha più nessun legame con essi. Il fatto di aver appartenuto
alla destra o alla sinistra diventa, in questa operazione, assolutamente
secondario, irrilevante, e appare invece creatore di senso, per il contrito,
solo l'annullamento totale dell'individuo che è stato, e che -ormai
guarito- egli consegna come un ingombro a un presente salvifico, fuori
dal tempo che, in questa visione conciliante, si pone al di sopra della
politica, che si è affrancata intanto dal concetto di colpa morale,
giudiziaria e li ha sostituiti con quelli di normalità, normalizzazione.
Questa impressione di volere annullare il passato, la storia degli anni
Settanta, che sta dietro alla proposta del vicedirettore del Corriere
della Sera, è stata resa ancora più netta nel corso della
trasmissione Otto e mezzo di venerdì 18 febbraio, durante la quale
egli ha avuto modo di approfondire il suo pensiero. Qualche giorno prima
Ritanna Armeni aveva scritto su Liberazione un bell'articolo in difesa
di quel periodo storico, Ma gli anni 70 non furono cupi . Purtroppo nel
corso della trasmissione essi sono apparsi non cupi, cupissimi, anche
se con tinte più grottesche che tragiche. Non c'era innanzitutto
nessun rappresentante della sinistra extraparlamentare di quegli anni
tranne Lanfranco Pace. C'erano invece accanto a lui almeno tre rappresentanti
della destra, fra i quali lo storico Accame.
Certamente, Lanfranco Pace ha testimoniato con gravità e visibile
sofferenza su quanto lo ha personalmente coinvolto in quegli anni. Ed
è giusto rispettare chi riconosce di aver commesso degli errori,
anche molto gravi, nel corso della sua militanza politica in quegli anni,
fino a pagarli con il carcere. Ma è anche vero che noi ci siamo
ritrovati davanti a degli ex in toto degli anni Settanta, a degli individui
come Pace, lo stesso Battista, lo stesso Giuliano Ferrara, che non hanno
chiuso soltanto con i loro errori del passato, ma considerano la concezione
politica che muoveva le loro azioni di allora esecrabile, non perchè
violenta, ma perché ideologicamente sbagliata. Essi si sono da
tempo dissociati da qualsiasi visione che si rifaccia ai valori democratici
della sinistra, quali si sono fortemente espressi in quegli anni, al di
là della violenza delle frange extraparlamentari e del terrorismo,
non hanno alcun interesse a ricordare le conquiste sociali ottenute attraverso
le lotte di quello stesso periodo, come aveva cercato invece di ricordare
nel suo articolo Ritanna Armeni, che purtroppo non ha avuto la possibilità
(o volutamente ha scelto di tenersi da parte ?) di ribadirlo nel corso
della trasmissione.
Quindi si è trattato di un discorso tra ex di quegli anni, che
ruotano oggi nell'aria governativa e rappresentanti della destra, oggi
"sdoganata" da Berlusconi, che hanno parlato soprattutto dei
loro anni Settanta, della discriminazione allora patita fino al punto
di ipotizzare un favoreggiamento occulto da parte della DC, che avrebbe
addirittura sguinzagliato contro di loro gli extraparlamentari di sinistra.
E il confronto, in assenza di una credibile impostazione storica, ha assunto
a tratti l' andamento un po' burino di un battibecco su chi aveva menato
o sparato, su chi le aveva prese o date in non si sa bene quali periferie
del Paese.
Tranne che in un breve cenno di Lanfranco Pace, nessun riferimento alle
stragi, ai mandanti, al sequestro di Aldo Moro, ai pesanti interrogativi
che stanno ancora dietro di esso, nessuna capacità di leggere i
motivi che spinsero tanti individui in quegli anni a scendere in piazza
in modo pacifico, che spinsero tante donne a riunirsi separatamente, interrogandosi
sul rapporto con l'uomo, con le proprie simili. Nessuna visione di ampio
respiro su quegli anni dove la violenza fu fronteggiata in particolare
dalle donne con nuove modalità del far polittica, che pur se non
furono raccolte, se non si estesero tra gli uomini e le donne che avevano
scelto la violenza come forma di lotta, hanno caratterizzato in modo ineludibile
gli anni Settanta.
E' chiaro quindi che nell'atmosfera di azzeramento, di non riconoscimento
di tutte le componenti di quel periodo storico, la proposta di Battista
suona, come dicevo prima, tutt'altro che rassicurante. Isolare la violenza
e farne il motivo dominante degli anni Settanta, accostandoli addirittura
al Ventennio fascista, come lui ha fatto, è un indice tutt'altro
che rassicurante di spostamento della politica, attraverso la proposta
di confessione, di ammissione pubblica delle proprie colpe, di un suo
slittamento, verso quel regime del normale -opposto ad anormale-, tecnica
di dominio del potere, che ha così bene individuato Michel Foucault,
e non certo democratico confronto.
In realtà, dietro la proposta apparentemente paciosa di pubblica
ammenda avanzata dal vicedirettore del Corriere, si intravede piuttosto
il rozzo, ma non per questo meno pericoloso, sogno di Berlusconi e del
suo entourage che alla politica come confronto, come dibattuito, alla
giustizia dei tribunali come luogo deputato a dirimere le colpe, vorrebbe
sostituire una sorta di "comune sentire della gente", com'è
venuto fuori più esplicitamente in occasione dell'assoluzione degli
islamici sospettati di terrorismo e nell'episodio dei nomadi sospettati
del rapimento di un bambino. Atteggiamento che in un suo articolo, apparso
alcuni giorni fa su Liberazione, Giuliano Pisapia fa risalire al
nazismo.
E' il tentativo di coinvolgere tutti in un comune, normale sentire, di
cancellare l'dea di contrapposizione e di confronto come esercizio democratico
sui quali gli anni Settanta della rivoluzione pacìfica, che ebbero
la forza di sussistere accanto a quelli della violenza, hanno pur dato
qualche lezione. Tutto dipende dalla volontà politica di coglierla
o meno, dalla volontà di isolare solo quello che ci fa comodo o
di saper guardare al di là del proprio "particulare".
In ogni caso non si può consegnare il proprio passato, il passato
di uomini e donne di una nazione, a chi vuole solo sotterrarlo.
4-04-05