Grazia Colombo, Emanuela Cocever, Letizia Bianchi, Il lavoro di cura. Come si impara, come si insegna
Quando
un manuale è utile anche per i/le non addetti/e ai lavori
di Adriana Perrotta Rabissi
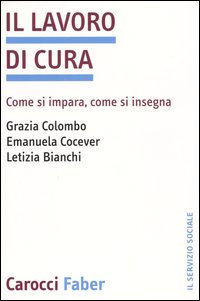
La forma
del libro è quella di un manuale, rivolto a chi vuole diventare
operatore/trice nei servizi socio-sanitari, corredato di esercizi di autoverifica
alla fine di ognuno dei cinque capitoli di cui si compone; è stato
scritto da tre donne impegnate da anni nella formazione del personale
e nella gestione dei servizi stessi.
E' da notare che tra i suggerimenti bibliografici se ne trovano, oltre
a quelli specialistici, anche alcuni di natura letteraria, per chi voglia
approfondire i temi del "curare" e dell'"essere curati".
Già questo elemento suggerisce che uno degli obiettivi principali
del testo, accanto a quello di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti,
è quello di creare e diffondere una "cultura della cura"
in una società come la nostra che svaluta nei fatti, enfatizzandolo
a parole, qualunque lavoro e/o attività che presenti un alto contenuto
di cura.
Si spiega così la tensione che percorre tutto il testo, volta a
fare uscire il lavoro di cura dal ghetto del privato/individuale in cui
è rinchiuso, per indagare la "condizione umana" dell'oggi,
nel nostro tempo/spazio culturale, a partire da una questione terminologica,
spesso sottovalutata ma ricca di implicazioni: il doppio significato del
verbo curare, nell'accezione medica e in quella antropologica di prendersi
cura di qualcuno.
Ad apertura di libro le parole della pedagogista di Myriam David offrono
la chiave di lettura:
"Non so se riuscirò a dire quello che voglio dire […]
Riguarda la mancanza di cura e quello che la cura porta […] non solo
ai bambini, ma, credo, all'umanità.
[…]
Credo che non si è detto, a proposito del fenomeno dei campi, di
un posto come Auschwitz, per esempio, e degli altri…non si è
detto che quello che è stato dinamico nel senso della distruzione,
è stato la non-cura assoluta… La non cura è l'assenza
di cibo o il cibo disgustoso, è la sporcizia disgustosa, sono i
vestiti disgustosi, lo sfinimento, l'assenza di sonno, è quello
che si fa al corpo".
Da questa scelta si comprende come le autrici procedano ad analizzare
e tematizzare prima di tutto la relazione tra chi cura e chi è
curato, nei vari contesti e nelle diverse situazioni: asili nido, ospedali,
scuole materne, case di riposo... e i rischi di sovraesposizione emotiva
a cui sono esposti/e gli operatori/trici, a causa della duplice dimensione
materiale e emozionale/affettiva in cui si trovano ad operare.
A cerchi concentrici l'attenzione si estende ai familiari dei soggetti,
bambini, anziani, malati, presi in cura, all'interazione tra questi e
le istituzioni che spesso richiedono l'aiuto dei familiari a patto che
questi seguano modelli di comportamento rigidamente prefissati e funzionali
all'autoriproduzione dei luoghi stessi in cui si erogano le cure.
Viene anche esaminata la contraddizione che spesso vivono le donne che
si occupano professionalmente della cura (e che sono ancora la maggioranza
degli addetti) contraddizione, a volte risolta e a volte no, tra l'esperienza
maturata nella propria vita di relazioni familiari e sociali e la tendenza
a disconoscerla nella quotidianità del lavoro, come un elemento
perturbante di una rigorosa professionalità.
L'insieme delle riflessioni presenti nel libro, riguardo un aspetto così
fondamentale della nostra vita, singola e collettiva, che ci vede, nel
corso del tempo, destinati/e a ricoprire quasi tutti i ruoli che chiama
in causa, mi sembra aiutino oltre che a comprendere, a governare lo stato
di ansia che ci coglie di fronte alle esperienze prevedibili e imprevedibili
che ci si presentano nel corso della vita.
Grazia
Colombo, Emanuela Cocever, Letizia Bianchi
Il lavoro di cura. Come si impara, come si insegna
Roma, Carocci Editore, 2004
pp.182, E. 16,80