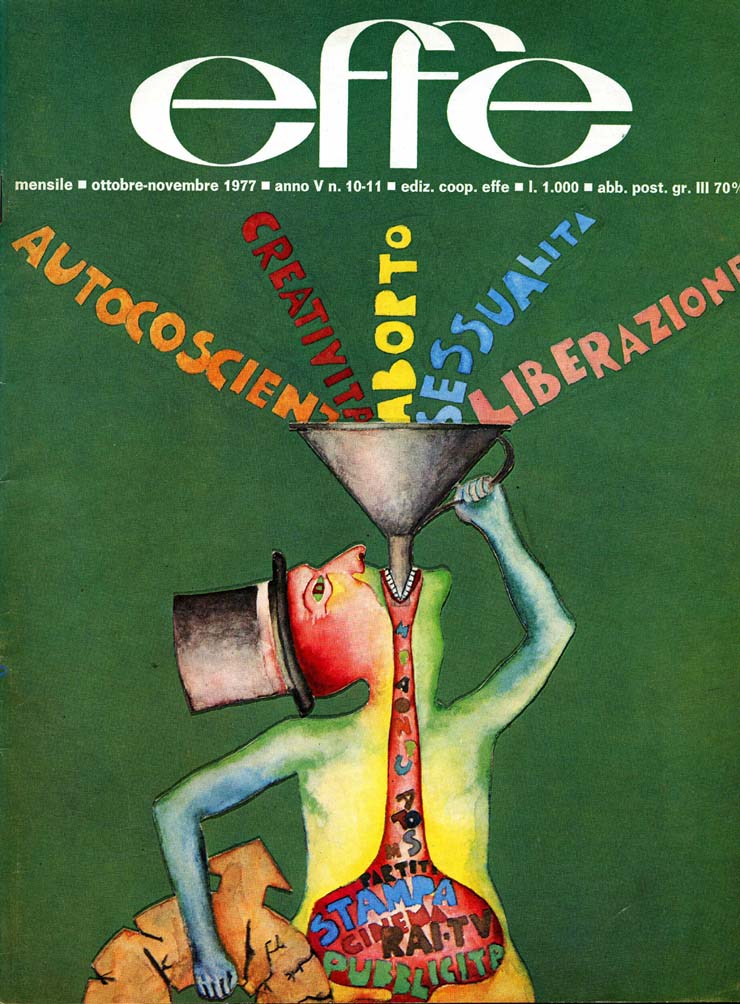|
All’ultimo respiro
di Bianca
Pomeranzi
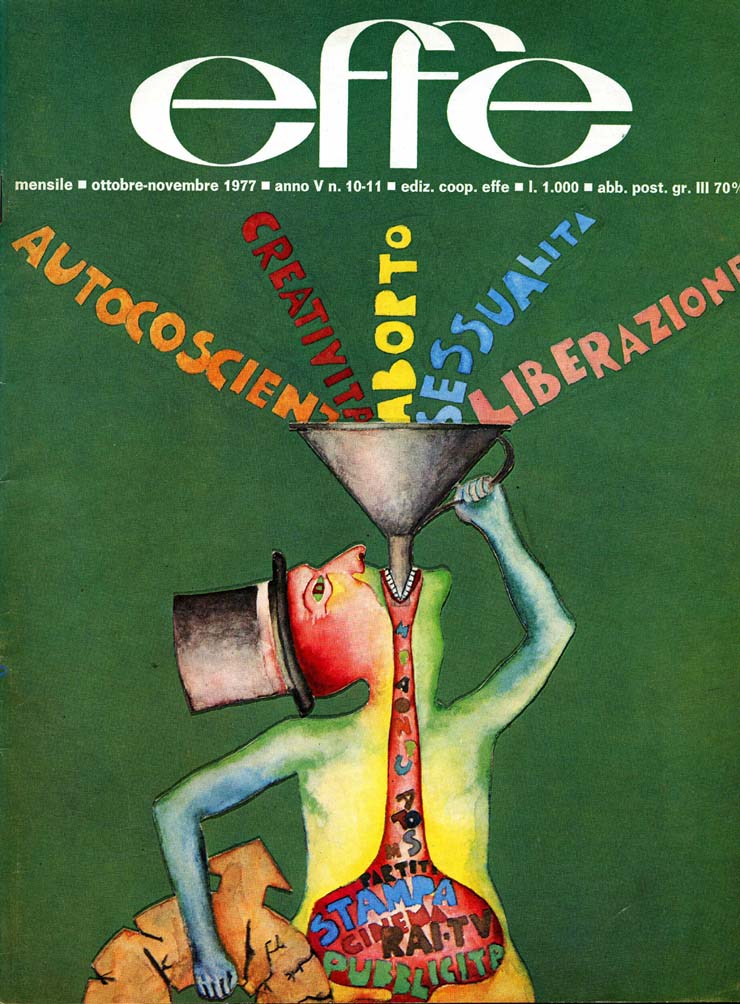
effe, n.10-11,
ottobre-novembre 1977
Per raccontare
bene il femminismo italiano e la sua particolarità, occorrerebbe uno
strumento come il grand'angolo, capace di cogliere il panorama di idee e
iniziative di quel movimento politico "separatista" che fu il femminismo
degli anni Settanta.
Da questo punto di vista il 1977 è probabilmente l'anno che segna un
passaggio di fase e anche quello più pericoloso politicamente perché il
movimento si trovò preso nella complicata stagione della politica
istituzionale italiana, con l'esplosione del movimento del '77 e il
terrorismo diffuso, ma soprattutto si trovò a dover fare i conti con la
propria crescita esponenziale.
Quello che stava dettando le proprie condizioni alla politica
istituzionale in tema di diritto di famiglia, di aborto di pari dignità
nel lavoro e di violenza sessuale era un "movimento tutto nostro", di
donne che avevano iniziato a parlare di sé in prima persona, che cercavano
la propria "singolare" libertà, che praticavano i testi e i contesti del
femminismo cercando di scegliere da che parte stare nella vita.
Almeno così ero
io, sbarcata a Roma dalla provincia toscana, dove ero stata folgorata
dalle letture e dalle frequentazioni di femministe romane, quasi tutte
lesbiche e comunque molto radicali. Le mie amiche venivano proprio da uno
dei gruppi più radicali e separatisti di Roma, ovvero il Movimento
femminista romano di via Pompeo Magno che inizialmente era stato uno dei
collettivi di Lotta femminista, ma, dopo il 1971, aveva preferito
procedere con una pratica politica in cui si alternava la "presa di
coscienza" con le azioni pubbliche e l'incontro con le donne nei quartieri
e nei mercati.
Era un collettivo con una sua storia già consolidata a cui io mi avvicinai
con rispetto e una grande voglia di imparare attraverso i racconti delle
altre, dando in cambio il mio tempo e la mia disponibilità alla
"militanza".
All'indomani del mio arrivo in pianta stabile a Roma, il 3 aprile 1976, in
coincidenza con la manifestazione sull'aborto che provocò la caduta del
Governo, mi trovai al centro dell'organizzazione e capii subito che quel
movimento di donne non nasceva dal nulla né era una esplosione casuale,
piuttosto l'esito di una pratica politica difficile con tanto di
personalità e gruppi leader, capaci di dettare una agenda politica
autonoma e di scendere in piazza aprendo un conflitto diretto anche con i
partiti egemoni del movimento operaio. Lo spirito dei tempi consentiva
tutto questo, anzi forse lo esigeva perché l'Italia aveva un grande
bisogno di modernizzazione e le donne stavano vincendo in tutto il mondo.
Già nel 1975 le femministe - riunite in un forum a Città del Messico per
la prima Conferenza Onu - avevano dimostrato di essere un movimento
internazionale, di avere capacità di trasformare le istituzioni, anche le
più lontane.
Quello che fu nuovo in Italia e quasi inaspettato fu la capacità di
portare il conflitto non solo nella vita famigliare e nelle relazioni
private, ma anche e soprattutto nelle piazze, nello spazio che fino allora
aveva risuonato di voci maschili e che divenne il teatro del femminismo
diffuso.
Nonostante la diversità dei linguaggi che derivavano dalle appartenenze
iniziali - più o meno vicine alla sinistra extraparlamentare, più o meno
legate al Partito radicale e alla lotta per il divorzio e per i diritti
liberali, più o meno sensibili alla cultura cattolica o ai movimenti
emancipazionisti della sinistra tradizionale - il movimento femminista
riusciva a far tesoro delle differenze e a creare una massa critica
visibile e autonoma "politicamente".
Usando il separatismo come uno strumento di aggregazione e senza entrare
nelle istituzioni, il movimento delle donne dal 1975 al 1977 condusse
"negoziati autorevoli" con la politica istituzionale e con il mondo dei
media.
Fu il punto più alto del movimento fatto di tanti piccoli collettivi,
diffuso capillarmente sul territorio, ma anche l'inizio delle divisioni.
Il 1977 è cruciale proprio per questo motivo. Alla manifestazione notturna
contro la violenza "Riprendiamoci la notte" nel novembre del 1976, a Roma,
erano comparse le donne dei gruppi dell'autonomia operaia, "casseuses"
ante litteram, a spaccare le vetrine di via Sistina.
Nel dicembre dello stesso anno, a Paestum, al terzo e ultimo convegno
femminista, si erano sentiti i primi scricchiolii nei conflitti tra Roma,
coinvolta nella politica, e Milano, con la sua rigorosa pratica
dell'inconscio.
Tuttavia fu
proprio nel corso del '77 che le differenze (a cui nel frattempo
era stata intitolata una rivista romana, gestita autonomamente e
solidarmente da diversi gruppi) esplosero.
Quando in maggio, a Roma, fu decisa l'adesione dei collettivi femministi
all'occupazione del Governo Vecchio, già avviata dall'Mld, vi aderirono
più di 70 gruppi.
Le numerose manifestazioni realizzate tra il '75 e il '76, oltre a
scuotere i Palazzi della politica istituzionale, avevano dunque coinvolto
un gran numero di donne.
C'era indubbiamente una "potenza" attrattiva in quelle manifestazioni
separatiste che si montavano in pochissimi giorni, anzi in poche ore, come
quella che facemmo all'Alberane nell'aprile del '77 quando Claudia Caputi,
già vittima di stupro da parte di un branco, fu di nuovo violentata.
Era una trappola
oscura che non capimmo e che in seguito produsse divisioni. Noi invece
lavoravamo per unire.
Stavamo ricucendo un nuovo legame anche con i collettivi del Salario al
lavoro domestico che in giugno avevano organizzato a Roma un Congresso
internazionale su "lavoro, sessualità, prostituzione".
Le manifestazioni erano preparate collegialmente, al punto che la vecchia
distinzione tra il gruppo marxista di via Pomponazzi e quello radicale di
via Pompeo Magno aveva perso senso e anche le sedi si erano avvicinate.
Nel 1977 molte di quelle di Pomponazzi avevano una sede a via Germanico, a
non più di 300 metri da via Pompeo Magno. Si lavorava spalla a spalla,
insieme per molta parte della settimana, ma stavamo bruciando i tempi di
riflessione. Alcuni collettivi si spaccavano sulla questione del lesbismo.
Verso la fine del 1977 il n. 4 di “Differenze”, redatto dal Pompeo Magno e
dedicato alla sessualità, aveva una intera sezione sul lesbismo.
Ma intorno
cresceva troppa violenza e le assemblee al Governo Vecchio diventavano
difficili.
A febbraio Lama era stato cacciato dall'università di Roma, a marzo a
Bologna durante gli scontri tra Comunione e liberazione e gli studenti la
polizia aveva ucciso Francesco Lorusso, a maggio era stata assassinata
“per errore” Giorgiana Masi.
Il centro di Roma era quasi sempre assediato dalla polizia e il terrorismo
diffuso lambiva frange di donne.
Si crearono nuove alleanze tra quelle che volevano un movimento femminista
autonomo e separatista. Eravamo forti e continuammo così fino alla
normalizzazione che seguì la morte di Moro e alla proposta di legge di
iniziativa popolare contro la violenza sessuale.
Poi quel movimento politico si perse in una miriade di associazioni.
Ancora oggi mi
chiedo se sia stata l'incapacità di gestire la nostra potenza o gli eventi
esterni a farci perdere l'occasione di cambiare per sempre la storia, però
è certo che allora vincemmo una vita nuova.
Questo scritto è stato
pubblicato in “70 gli anni in cui il futuro incominciò” n.8/1977.
10/06/2007 |