|
da
Liberazione del 12 Gennaio 2005
E SE IL PROBLEMA FOSSE …
di Bianca Pomeranzi
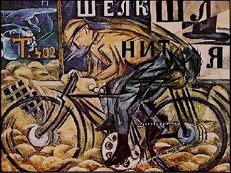
Natalia Goncharova
Sono particolarmente
interessata al dibattito sul femminismo che Liberazione sta, molto
intelligentemente, ospitando perché verte su temi a me molto cari: la
politicità del femminismo e il dialogo tra il femminismo definito
“storico” ( mi ricordo quando accadde che ci chiamarono così, alla fine
degli anni settanta, e molte di noi, me compresa, avevano meno di trenta
anni) e le nuove generazioni di donne che vivono una serie di possibilità
e contraddizioni diverse da quelle che noi abbiamo conosciuto e che ci
consentirono un potente slancio liberatorio.
Tutti gli interventi
mi sono sembrati interessanti, tuttavia gli articoli finora apparsi
toccano in modo trasversale, senza affrontarlo direttamente, uno dei punti
dolenti del femminismo contemporaneo: l’incapacità di incarnare il punto
di vista delle donne in un orizzonte politico complessivo. Su questo le
reazioni sono differenti: dalla domanda di Melandri sul silenzio delle
femministe, alla strenua difesa di Cirillo delle nuove generazioni. In
molti articoli, tranne forse che in quello di Paolozzi, c’è una implicita
accusa al femminismo di mancato ascolto e di mancata mediazione, da cui
deriverebbe l’afasia femminile. Anzi di più, sarebbero proprio le lobby
femministe a impedire il confronto e a togliere spazio alle nuove idee
delle donne.
A questo, che
considero un punto politico di grande importanza intendo obiettare, in
quanto ritengo che il problema sia mal posto poiché non tiene conto del
rapporto tra donne e “spazio pubblico” nella storia recente, sia in Italia
che nel mondo. Uso il termine “spazio pubblico” in una accezione che
comprende non solo le istituzioni della politica, ma anche i vari livelli
e le varie forme di scambio culturale e sociale tra attori pubblici e
privati, poiché a mio parere consente di articolare con maggior forza la
grande proposta “politica” del neo-femminismo.
Infatti l’avere
dichiarato che “il personale è politico” ha consentito a intere
generazioni di donne, non solo occidentali, non solo bianche, non solo
laiche, di avviare quel “salto di civiltà” necessario alla nuova
convivenza globale: ovvero a farsi soggetti e svelare la politicità del
dominio patriarcale.
In questo percorso di
soggettivizzazione il femminismo, iniziato quasi contemporaneamente e per
motivi diversi, nel Nord e nel Sud del mondo, ha incarnato per più di
dieci anni, dagli anni settanta agli anni ottanta, la vivezza e
l’intelligenza di un rinnovamento della “politica”, movendosi come
un’onda lunga di cui solo oggi è possibile capire la portata trasformativa.
Quel femminismo però
si scontrava con enormi difficoltà, prima fra tutte quella di far
dialogare donne “situate” in contesti differenti per classe, razza e
generazione. Da una parte infatti, quel “personale/ politico” così
forte, ma anche così “incarnato” nella materialità delle singole vite,
tendeva a disperdersi in molteplici battaglie, a volte anche in
contraddizione tra di loro. Dall’altra veniva risucchiato all’interno
della politica istituzionale. Questo è successo nel corso degli anni
novanta in Italia e nel mondo.
Questo deve a mio
parere essere tenuto in considerazione quando vogliamo rileggere la nostra
storia che è personale, quindi fatta di memorie, coscienze, relazioni, ma
anche politica. Su tutto questo c’è da anni un pensiero, non solo
eurocentrico, e un confronto tra femministe, su cui però è calato
il silenzio, forse perché è un pensiero scomodo per gli opposti
antagonismi patriarcali o forse perché “eccede” il livello della politica
tradizionale di destra e di sinistra. Eppure quel “punto di vista”, anzi
quella ricerca di un nuovo orizzonte di convivenza, potrebbe fornire una
chiave di interpretazione anche ai concitati eventi che si sono susseguiti
dopo la caduta del muro di Berlino, potrebbe interrogare le basi
stesse dell’equilibrio “geopolitico” mondiale, ovvero svelare come la
forza e la paura siano tutt’oggi il paradigma ordinatore della relazione
umana, da quella tra sessi a quella tra culture differenti o tra
differenti poteri sociali.
Tuttavia quel
personale/politico non è una teoria facile da declinare, soprattutto se la
politica istituzionale si irrigidisce su vecchie formule e se il partire
da sé, variamente coniugato, fa scattare la babele delle differenze. In
Italia, ad esempio, la sinistra, meglio le sinistre, hanno reagito in modo
ostile al femminismo, soprattutto negli anni novanta. La fine della prima
Repubblica ha interrotto lo schema di comunicazione che si era creato tra
movimento femminista e rappresentanza politica per circa venti anni.
Le idee del
femminismo sono state ascoltate solo fino a quando sono state
funzionali alla nuova classe dirigente di donne politiche in formazione,
poi maschi e femmine hanno pensato di potersi finalmente liberare del
fardello del femminismo (come di molti altri ismi) o, al più, di
utilizzarne l’appeal. Tutto ciò emerse con grande chiarezza dieci anni fa
durante la manifestazione a sostegno della legge sull’aborto del 3 Giugno
1995 “La prima parola e l’ultima”, quando un universo variegato di donne
dette vita a una manifestazione molto efficace, ma controversa.
Certamente in quell’occasione noi femministe facemmo l’errore di pensare
che le nostre pratiche, ormai vissute soprattutto in luoghi associativi e
ristretti, potessero tornare a manifestare al mondo una coscienza
femminile che in realtà non si percepiva più come tale.
Il femminismo
infatti, nel mondo e in Italia in particolare, ha un grande respiro e
necessita di tempi e spazi che spesso non coincidono con quelli della
politica istituzionale. Tuttavia le femministe italiane hanno certamente
fatto molti sforzi per trasformare la politica istituzionale e per
confrontarsi con le nuove generazioni. Non sono dunque d’accordo
sulla supposta autoreferenzialità del femminismo.
Nel corso degli
ultimi anni tutte le riviste e i giornali femministi ‘superstiti’ si sono
sempre interrogati sugli incroci tra la differenza sessuale e le
differenze generazionali, razziali e culturali. Eppure i media, che, non
solo in Italia, prendono in considerazione solo quelle donne che fanno
parte del movimento dei movimenti, sembrano non sapere che nel Forum
Sociale non ci sono solo le Arundati Roy, o le donne della Marcia
Mondiale, ma anche specifici appuntamenti delle femministe
trans-nazionali.
Anche quest’anno a
Porto Alegre, ad esempio, come l’anno scorso a Mumbai, ci sarà un
incontro con più di trecento di femministe “pensanti”.
Probabilmente, come è successo a Firenze nel 2002, anche loro saranno
relegate in luoghi e in orari di minore importanza, secondo una precisa
gerarchia voluta da chi organizza.
Le femministe dunque,
soprattutto quelle storiche, continuano a parlare e lavorare, ma i loro
sforzi, chissà perché, non sono considerati. Chi scrive, ad esempio, ha
organizzato per due anni alla Casa Internazionale delle donne di Roma una
serie di “dialoghi sulla globalizzazione” invitando donne di generazioni e
di pratiche politiche differenti, in gran parte legate al movimento
altermondialista. Gli inviti non sono stati tuttavia ricambiati. Sembra
dunque, per tornare al dibattito sul silenzio del femminismo, che le
“pratiche” femministe più originali, quelle che continuano la svolta
epistemologica della soggettività femminile, seppure essenziale per la
politica contemporanea, siano ancora troppo scomode.
Quindi vale forse la
pena di chiedersi e di chiedere se non è tanto l’autoreferenzialità a
costituire il problema, quanto piuttosto la mancanza di un sistema di
mediazione “politica”, interrotto da più di dieci anni . Se così fosse,
allora non è solo un problema tra femministe di varie generazioni, ma tra
femministe e politici e politiche delle istituzioni e dei movimenti.
|