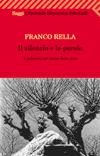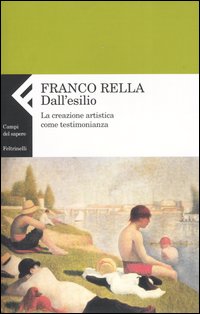|
Una lettura intensa e erratica di Franco
Rella, scrittore che parte da sé per raccontare l'impresentabile della
vita
Morte, dolore,
felicità, corpo
di Lea Melandri

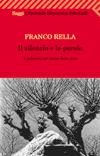
In un libro ingiustamente dimenticato di
Alberto Asor Rosa, L'ultimo
paradosso (Einaudi 1986), si legge: «E' una singolare facoltà del
pensiero umano potersi pensare al di fuori del vincolo biologico e
costruire su questa persuasione persino dei sistemi. Ma quanto più esso si
ritira o s'affonda, tanto più registra e descrive soltanto ciò che esso
stesso è: si avvicina, pur senza ovviamente raggiungerla mai, alla
individuazione degli elementi oltre i quali non c'è nulla di ulteriormente
scomponibile, e lo sguardo comincia ad affondare nel buio. Diventa cioè un
resoconto, anzi un racconto della nostra propria conformazione materiale,
racconta la vita, è la vita».

Alberto Asor Rosa
Con la messa a morte del corpo, il pensiero occidentale inaugura il suo
cammino verso una conoscenza convinta di potersi liberare dal suo peggior
nemico, la finitezza dell'essere umano, ma, così facendo, ha aperto anche
la strada a quanti, per nostalgia, tenteranno il viaggio all'incontrario,
sapendo di aver sepolto in quell' "involucro terroso e opaco" tesori di
cultura, che ci sono, come dice Asor Rosa, e "basterebbe cercarli".
A forzare i confini delle estreme regioni in cui sono finiti, insieme alle
radici corporee, molti altri aspetti impresentabili della vita - la gioia,
la sofferenza, il male, la vecchiaia, la morte - sono stati storicamente
linguaggi, come l'arte e la letteratura, capaci di dare forma e
rappresentabilità a tutto ciò che risulta invisibile al pensiero logico.
Dove è sembrato che la Storia si lasciasse dietro ampie zone oscure e
insondate, sono sempre state le storie, i racconti di vita, a restituire
un'immagine più autentica dell'uomo e della sua civiltà. Ai poeti, agli
artisti, ai narratori, sarebbe toccata la sorte dell'esule - messo a nudo
dalla perdita delle proprie abitudini e perciò più vicino a vedere lo
straniero che è dentro di sé - e il compito del testimone sopravvissuto
all'orrore e agli inabissamenti in cui veniamo precipitati dal mal di
vivere, e, proprio per questo, tenuto a darne testimonianza.
A richiamare, con un'insistenza quasi ossessiva, questa responsabilità
etica della letteratura e dell'arte, non poteva che essere un filosofo
disposto a spingersi, con un viaggio riparatore, ai bordi del sapere che
più di ogni altro si è accanito sulle sue origini. Ai confini del
corpo (Feltrinelli 2000) è il libro con cui
Franco Rella imprime
alla sua lunga appassionata ricerca di anni intorno al tema "il silenzio e
le parole" una svolta originale, per quanto solitaria nel panorama
italiano.

Franco Rella
Anche se si tratta di un cammino che lo vede accompagnato e confuso, in
una sorta di "deriva morenica", con le mille voci degli autori che hanno
aperto strade al suo pensiero, l'interrogativo con cui Rella si accinge a
trasformare i confini in passaggi verso nuove, imprevedibili conoscenze, è
di quelli che non si possono dire a un convegno, se non con dolore e
disagio: «E io? Io e il mio corpo?». «Non posso parlare in un convegno del
male dell'insonnia, della morte. Se ne parlo non posso che parlare del mio
male, della mia insonnia, della mia percezione della morte. Una
confessione? Non ho mai tenuto diari, anche se questi appunti ne hanno
l'aspetto: una viscida secrezione del mio male di vivere. Come posso
separare il mio discorso da tutto questo?».
Figure del male (Feltrinelli 2002), da cui è tratta questa
citazione, è solo una delle soglie intorno a cui si incontrano e si
contagiano l'orrore muto e la parola che tenta di stanarlo, l'eterno
presente della fame, della necessità, della vecchiaia, di tutte le
passioni che si spengono in un urlo, in un mugolio sommerso, e la lingua
erratica che vorrebbe captarne almeno un suono o un'immagine.
Prima e dopo vengono Di fronte all'indicibile
(in Pathos,
Pendragon 2000), Dall'esilio (Feltrinelli 2004),
Pensare e cantare la morte (Nino Aragno editore 2004).
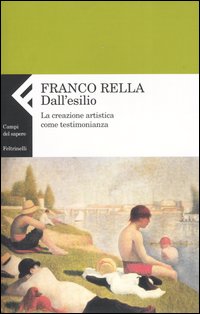
Contro l'acclimatamento all'orribile, quello che occupa la scena del
mondo, ma anche quello che attraversa ogni vita, dal male fisico al mal di
vivere, all'agonia della morte, la salvezza sembra che possa venire solo
dalla fede nella parola che, per quanto inadeguata, ha la capacità di
ascolto e la compassione necessarie per assumersi la «responsabilità di
rappresentare l'irrappresentabile».
Ma con quale parola addentrarsi nelle «zone più oscure e opache dell'io»,
con quale scrittura dire la nudità delle vittime dei campi, la nudità dei
derelitti, la nudità di ogni essere umano di fronte al male e alla morte?
Sono davvero soltanto l'arte e la letteratura a sporgersi sulle macerie
che la ragione storica si lascia dietro? La salvezza sta davvero nel
trasformare una scia di immondizie - passioni impresentabili della vita -
in versi perfettamente puri?
La tentazione di consegnare le esperienze essenziali dell'umano ai
linguaggi che, per nostalgia, sono andati più vicino ai luoghi
dell'origine - il femminile, il corpo, l'infanzia, i patimenti - viene
comunque da quel versante della storia che si è arrogato il potere di
innalzare steccati tra biologia e storia, tra corpo e mente, maschio e
femmina, sessualità e politica, e che, insieme a una pesante cesura, ha
posto anche le condizioni perché qualcuno tentasse di sanarla. Non c'è
dominio di padri che non corra il rischio di vedersi sorgere a fianco il
desiderio dissidente di un figlio, non c'è pensiero logico che non sia
stato interrogato e scalfito dalle ragioni del sentimento, non c'è
scrittura, per quanto salvifica, che non abbia conosciuto il mal di
scrivere, il gelo e la solitudine da cui, come dice Proust, nascono i
libri.
Chi tenta il viaggio di avvicinamento al "cuore di tenebra" della civiltà
e di ogni individuo, sa di poter contare su una navicella fragile, una
parola vacillante «come un filo teso che in ogni istante può spezzarsi».
«Magari a interromperlo - scrive Rella - è l'urlìo che sale dalla strada e
che entra lacerante nel buio della stanza. O è la passione politica di
Augusto che pretende per Roma l'opera poetica, e assegna ad essa una
funzione sociale e politica. Ma il pericolo maggiore sta nella bellezza,
quando questa diventa il fine della poesia. Il suo contenuto si dissolve
nella vuota forma».
E' questa consapevolezza che impedisce al singolare percorso di pensiero e
di scrittura di Franco Rella di fermarsi all'incontro di arte e filosofia,
di accontentarsi della trama che vanno intessendo da anni dentro i suoi
scritti poeti, pittori, narratori amati, come Kafka, Flaubert, Proust,
Baudelaire, Rimbaud, Cèzanne, Valèry. C'è un momento in cui i libri, che
hanno aperto passaggi insperati al pensiero, diventano essi stessi il muro
che impedisce di andare oltre: «Ho studiato filosofia, diritto e teologia.
Quali risposte ho trovato? Ho percorso sentieri che mi hanno dato
felicità. Idee che mi hanno inebriato. Poi mi sono trovato improvvisamente
di fronte a un quesito che non ha risposta. Questo mi è capitato in una
fase della mia vita in cui mi sento scorticato, in cui anche l'aria che
gira intorno a me è atroce dolore». Il quesito non poteva essere che
quello estremo: come dare figura alla morte, e a quella morte in vita che
è la vecchiaia, come impedire che la ribellione alla finitezza umana
continui a generare una violenza mortifera, come impedire che il
sentimento dell'ultimo, invalicabile confine produca anche lo
sgretolamento definitivo della parola che vorrebbe rappresentarlo.
Se dall'esilio conseguente all'insorgere di una qualche passione si può
sempre tornare a dare testimonianza col racconto, dal vuoto o dal nulla
evocato dalla percezione della morte, anche la poesia è spinta a
interrogarsi sui suoi limiti.
Alcuni grandi poeti hanno tentato in vario modo di sfuggire al fascino di
una parola piena, pietrificata nella sua perfezione, e testimone solo di
se stessa. Ne è uscita talvolta un'opera «tagliata in frammenti», fatta di
«ossessive reiterazioni, note, aforismi, una prosa mobile capace di
cogliere i soprassalti della coscienza e gli intrighi della vita moderna»,
come nel Mon coeur mis à nu di Baudelaire; una scrittura che, per
voler tenere dentro la morte, sopporta di «essere sempre sul punto di
sfaldarsi».
Ma se questi sono i percorsi degli scrittori che Rella ha amato e a cui
sembra voler lasciare l'ultima parola nel libro Pensare e cantare la
morte, resta da chiedersi con quale lingua con quale narrazione abbia
costruito a più riprese il suo cammino, intarsiato delle loro figure, ma
pur sempre dislocato quanto basta per mostrarle. Gli ultimi tre libri di
Rella non sono riconducibili a nessun genere in particolare, anche se dice
lui stesso di averne tentati molti. Quando si è consapevoli che le nostre
vite e i nostri pensieri sono il sedimento di tante storie, anche il
linguaggio e i saperi si riconoscono intrecciati e confusi da sempre, per
cui non ci si meraviglia di incontrare nelle stesse pagine teoria e
racconto, immagini del mondo e scrittura di sé, riflessione sistematica e
frammento.
Ma dal libro con cui comincia il viaggio, Ai confini del corpo, definito
dall'autore stesso «un saggio audace che si legge come un romanzo»,
qualcosa, strada facendo, sembra essere cambiato. Il pathos che si vuole
restituire al pensiero, nel momento in cui riscopre i suoi aspetti meno
presentabili, lascia anche il testimone che ha osato tanto in una nudità
dolorosa, incerto sulle forme più adeguate per esprimerla, o addirittura
col dubbio di riuscire a farlo.
«Ho scritto molti saggi, alcune narrazioni e delle poesie. Mi pare che,
curiosamente, i miei saggi, più che la scrittura cosiddetta creativa,
abbiano una trama e che questa trama abbia condotto il mio pensiero a
delle aperture su una dimensione ulteriore del male».
«Cosa posso dire io di fronte a questi appunti, che si rifiutano a ogni
forma, che sfuggono da tutte le parti, che si muovono come vogliono, senza
che io possa né dirigerli, e nemmeno raccoglierli in una qualsiasi
trama?».
Se non è la letteratura e nemmeno il diario, ad accogliere intuizioni,
frammenti di discorso, silenzi improvvisi che sfuggono a ogni forma, come
altro chiamare questa scrittura che va così vicina alla vita da rischiare
di perdersi con essa, se non "scrittura di esperienza", luogo di singolare
contaminazione tra sé e mondo, emozioni e ragionamenti, silenzio e parole?
questo articolo è apparso su
Liberazione del 26 febbraio 2005
|