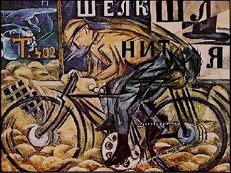|
|
|
sono un’insegnante di Storia e Filosofia del Liceo Novello di Codogno (prov. di Lodi). Ho avuto il piacere di leggere il Suo “Cromwell e Afrodite” ed ho visto in rete i pezzi su di esso e su “William Blake & internet”. Poiché già da qualche anno mi occupo dei temi da Lei trattati (e di altri ad essi collegati), ho infatti letto una buona parte dei testi da Lei citati, quelli della tradizione femminile/femminista, ed altri che lei non cita ma io considero fondamentali, anche dal punto di vista della sua tesi, mi sento di comunicarLe alcuni dati relativi alla questione emersi dai miei interessi. A partire dalla sua tesi, credo sia utile che veda anche “Le Filosofe” di Giulio De Martino e Marina Bruzzese, dove emergono dati importanti rispetto alla posizione delle donne delle classi dominanti tra Cinquecento e Settecento, anche in riferimento ai loro rapporti con gli intellettuali della cultura ufficiale del loro tempo e al loro contributo in essa. Interessante trovo che sia Marie De Gournay (1565 – 1645), la prima donna che ha scritto “Dell’Uguaglianza degli uomini e delle Donne”. Andrebbero studiate anche le femministe francesi (Le Preziose, le Cartesiane, poi le Illuministe) e le venete dell’epoca, (Lucrezia Marinelli scrive “La Nobiltà e l’Eccellenza delle Donne co’ difetti et mancamenti degli uomini” , nel 1601, richiamando esplicitamente il mito matriarcale delle Amazzoni ed usando il mito come una forma di racconto storico). Esse vengono regolarmente snobbate dalla cultura ufficiale: che sia quel fenomeno di cui Lei dice è ammalata la critica storica maschile rispetto a amazzoni, baccanti, streghe e quant’altro? Altro testo illuminante, oltre a Gimbutas che lei cita, è quello dell’antropologa Riane Eisler “Il Piacere è sacro, Il mito del sesso come purificazione” edizione Frassinelli; non sono riuscita a trovare, non ne ho i mezzi ma a Lei, se vorrà, non sarà difficile, della stessa autrice “Il calice e la Spada”. La prego di credere che la decisione di scriverLe proviene da un reale interesse per la materia e non da arroganza. Inoltre credo che il far parte di una certa tradizione, marxista e femminista, mi avvicini simpateticamente a chi ricerca nel mio stesso campo e da un punto di vista in un certo senso convergente: spero che comprenderà che mi piacerebbe avere uno scambio d’idee diretto. Non ho il suo indirizzo in internet, la lettera di vecchio tipo mi è sembrata l’idea più ovvia. Spero che non ne sia disturbato. Come Le dicevo, ho usato/sto usando altri testi: Cassandra e Medea di Christa Wolf, che Lei certamente conosce; ma ho letto anche volentieri alcuni testi di Vanna De Angelis: Le Streghe e Amazzoni, della Piemme libri, dove le sue tesi vengono più volte citate e commentate, da lì è nata l’idea di cercare di leggere da Lei stesso le Sue tesi. Come vede ancora una volta, pur vivendo in un ambiente di sinistra (ho fatto parte dal suo sorgere del Forum delle Donne del Prc, - della Marcia Mondiale delle Donne e della Cgil scuola finora – dove fior di intellettuali riflettono e studiano su questi ed altri problemi con un alto, notevole, livello di qualità della ricerca, nel silenzio dei media e senza mezzi), ma, dicevo, non è stata Monica Lanfranco a parlarmi delle sue ricerche, probabilmente non è nel suo carattere, una volta procacciatosi un contatto, di metterne al corrente le compagne del movimento di cui fa parte; è stata la lettura di Vanna De Angelis a mettermene al corrente. Lo stesso dicasi per Lidia Menapace. Ancora: rispetto al Novecento credo vada visto Bulgakov e il suo Il Maestro e Margherita, dato che nel libro si potrebbe dire, sempre sul filo della sua tesi con tutta la particolarità che Lei attribuisce alla situazione russa, motivi gnostici e magico- ermetici trovano una perfetta e gustosa armonia. Per quanto riguarda la Rivoluzione scientifica del Seicento, immagino che Lei conosca già il saggio di Paolo Rossi, La nascita della scienza moderna in Europa, e la sua analisi degli interessi esoterici e biblici di Newton, da cui emergono non solo le nevrosi dello scienziato, ma anche il suo essere sostanzialmente eretico oltre che opportunista nel saper scegliere per la stampa gli scritti dai quali sapeva che non gli sarebbero venuti guai giudiziari e/o religiosi, né che facessero ombra alla sua fama. Immagino che Lei conosca anche scienziati contemporanei come Fritiof Capra e filosofi come Umberto Galimberti, non voglio quindi andare oltre nei miei consigli di lettura. Questi ed altri testi, come quelli delle storiche delle Annales con la loro famosa Storia delle Donne a cura di Duby e Perrot, mi hanno stimolato da anni ad approfondire una serie di temi che, come Lei forse per primo ha visto nella critica maschile, vengono regolarmente elusi, minimizzati o peggio, taciuti, dalla cultura ufficiale, cioè dominante. Non so se Lei (oltre Lanfranco e Menapace) ha conosciuto da vicino l’esperienza del “Movimento dei Movimenti”: al suo interno esistono forti correnti con caratteristiche antiautoritarie, egualitarie, femminili e femministe, nonché oliste e stregoniche. Forte è la corrente Wicca. Lanfranco le avrà parlato di Starhawk e della danza a spirale che abbiamo fatto sulla spiaggia di Genova per il Forum sociale che in questi giorni si commemora. Lei stesso cita Mary Daly che Luciana Percovich ha invitata in Italia per presentare il suo nuovo libro, Amazon Grace, di prossima uscita, ma non soltanto, anche per creare una rete di rapporti tra noi. Perché, vede prof. Galli, il femminismo non è morto, è solo cambiato. Un po’ si integra alla ricerca di percorsi di affermazione personale che emergono dopo una fase di notorietà, acquisita, a torto o a ragione, grazie al movimento. Anche questi forse servono. Molto invece si costruisce come rete di relazioni; vero che i media non danno spazio alcuno a queste reti. Ma pensi all’esperienza dell’Università delle Donne, ai semi che da decenni lascia tra le donne, tra le lavoratrici e tra le intellettuali, con i suoi corsi che sono di fatto ricerca-azione. Mi scusi se ancora do dei consigli, ma gli studi di Percovich e di Sara Sesti su Mito e Scienza sono decisamente di pregio, non foss’altro perché non ce ne sono molti e non di questo livello, li trova pubblicizzati sul sito dell’Università. Li legga. Ben altro da quello a cui lei sembra far cenno rispetto alla realtà intellettuale italiana femminista di questi ultimi anni. E per l’interpretazione di Braidotti e De Lauretis, quest’ultima che Lei non cita ma immagino conosca, molto meglio Lidia Cirillo e l’esperienza dei Quaderni Viola di Milano. Cerco di sintetizzare il più brevemente possibile alcune tra le mie critiche più importanti, anche perché immagino che a questo punto se le aspetti. Pur avendo fatto parte dei movimenti almeno fino al Forum sociale di Parigi del 2003, ultimamente ho smesso di andare in giro, per mancanza di fondi; ho 51 anni, l’età e il disincanto che gli è proprio mi preservano da ogni disillusione: ma non potrei perdere quest’occasione. Le numererò. 1) Nessun cambiamento del ceto/nel ceto politico occidentale potrà cambiare l’attuale stato di cose per due diversi motivi: - le masse e non le élite fanno la storia e Lei lo dimostra, dobbiamo guardare con attenzione le sperimentazioni in atto a livello mondiale nel movimento dei movimenti, per individuarne i limiti ma anche per cercare là nuovi modelli e nuove formule, una sorta di Nuova Democrazia (avverto che la mia prima formazione politica è stata maoista); l’avvenire dell’Europa dipende da quanto saprà saldare la sua formazione a quelle istanze; - se non si cambia l’attuale assetto economico mondiale nessuna modificazione potrà essere significativa; se si continua a parlare di cambiamento politico senza mettere in campo le enormi disuguaglianze economiche (tra Nord e Sud del mondo, tra nativi/native e migranti, tra paesi che possiedono enormi quantità di strumenti di morte ormai sofisticati fino alla nausea, e paesi che non controllano nulla delle risorse del loro paese e che o subiscono le guerre o le fanno sponsorizzate dai paesi occidentali per trucidare in terribili lotte civili popolazioni loro simili; e poi da noi: demolizione dello stato sociale, terribile legge sulle TRA, fortemente ideologica, antifemminile e antifemminista, deregolamentazione del mercato del lavoro, disoccupazione e precarizzazione della vita quotidiana, integralismo religioso che minaccia lo Stato laico e la stessa formazione dell’Europa), se non si mette in discussione tutto questo ed altro ancora, allora si fa solo “ideologia”, quella deteriore di cui parlava il migliore Marx e che serve a conservare l’esistente. 2) La sua tesi è tuttavia affascinante: ma se la storia si sviluppasse come conflitto più tra i sessi che tra le classi, allora avrebbero ragione le teoriche femministe della differenza sessuale, le teoriche del sessismo. Il problema è capire che l’interesse economico è qualcosa di complesso: esso mette in campo emozioni, paure, viltà e coraggio, passioni ancestrali, non è quello di cui parlano i giornali nelle pagine economiche; da questo punto di vista è possibile combinare interesse economico e interesse alla procreazione, interesse all’accesso alle risorse disponibili in un territorio e interesse a tramandare contro altri il diritto all’uso delle risorse. Al di là del fatto che la scienza abbia dimostrato la superiorità dell’importanza biologica delle donne per la specie, bisogna comunque accettare che il potere riproduttivo è un potere, e per adesso lo posseggono le donne. È nella lotta per l’accesso alle risorse che il corpo della donna si fa risorsa: le guerre balcaniche insegnano (cfr. anche La Balcanizzazione della ragione di Rada Ivecovic). Tuttavia la Globalizzazione è una guerra non sempre guerreggiata. Il corpo femminile oggi è preda –predata di guerre nelle quali la sopravvivenza di gruppi umani più o meno “piccoli” è devastata, saccheggiata dai processi di privatizzazione /appropriazione / occupazione delle risorse, processi che noi chiamiamo “globalizzazione”, da parte di ristrette élite economiche a livello planetario. Perché non ipotizzare che meccanismi simili si siano sviluppati anche nel passato? La risposta è là. La scienza per millenni ha pensato la donna / natura come corpo / passività della quale scoprire i segreti per volgerli a favore dell’uomo, nel senso letterale del termine, anzi si potrebbe dire che è nata per questo; ma tuttora, anche nell’epoca della clonazione, essa non riesce a fare a meno del corpo femminile, cioè della donna, per procreare. Così come non riesce a fare a meno di mangiare, di vestirsi e coprirsi dalle intemperie. Il problema della donna –corpo –risorsa è simile a quello del lavoratore –forza-lavoro –risorsa, ma non è lo stesso, non può essere lo stesso. Dal padrone all’operaio infatti non passa amore, passione, affetto, desiderio. Taglio. Ergo: 3) I movimenti storicamente ci insegnano l’importanza delle relazioni; persino la merce è relazione: lavoro coagulato attraverso il quale un lavoratore, una lavoratrice comunicano con altri /altre lavoratori /lavoratrici: persone che si scambiano così relazioni; da questo punto di vista chi è fuori da una rete di relazioni perché potendolo non scambia nulla, ma dilapida soltanto, è dannoso per la società. Lei ha il coraggio di dirlo? 4) La relazione tra Magia e Rivoluzione scientifica è molto più profonda di quanto si voglia dire: in realtà Lei stesso mette in luce che il cosiddetto occulto è in realtà storicamente un occultato. Una serie di studi recenti, tra i quali lo stesso saggio di Rossi sopra citato, mostrano il saccheggio che la nascente scienza fece dei saperi delle donne, dalla medicina all’atteggiamento sperimentale, all’attitudine alla misurazione di ciò che si mescola in erboristeria e in omeopatia: atteggiamento tipico delle donne in cucina nel segnare e preparare gli ingredienti delle loro ricette. Ma non fu il primo: altri saccheggi erano stati consumati in tempi molto più antichi. Le Amazzoni e le Baccanti erano eredi di un potere perduto che già nell’antichità aveva creato Sapere, la Sapienza antica, antecedente diretto della filosofia. Tali saccheggi non sono stati affatto razionali o scientifici, furono piuttosto il risultato di terribili forze emotive. Essi hanno comportato la perdita di un incalcolabile quantità di informazioni, tramandate di madre in figlia attraverso i secoli, che oggi solo a tratti le ricerche consentono di intravedere. Basti pensare all’uso medico e consapevole delle sostanze stupefacenti. Bisogna inoltre chiedersi perché la chimica, decisamente più antica di altre scienze, si sia consolidata così tardi e ad opera di uno scienziato che di suo inventò ben poco, ma seppe opportunisticamente utilizzare ciò che altri avevano scoperto, quale fu Lavoisier (vedi H²O, Una biografia dell’acqua, di Philip Ball), e guarda caso nello stesso periodo della rivoluzione francese. Bisogna ripensare il concetto di ragione che con Bacone ha preteso di affermarsi sulla natura e sulla donna come dominio e con Cartesio ha alienato l’uomo da se stesso, annichilendone la personalità, repressa a tal punto da poter rendere al massimo nel lavoro (cfr. Freud, Il Disagio della Civiltà e altri saggi): ottimo metodo per lo sviluppo economico (ma lo fu?) costruito sull’oppressione. Quel tipo di ragione ha fatto solo danni e oggi si sta rivoltando contro se stessa e i suoi sostenitori. Anche il campo di concentramento ne è stato un risultato, particolarmente efferato, ma conseguente a quell’impostazione. Concordo con l’interpretazione che collega Totalitarismi – Antisemitismo- Caccia alle Streghe, in un modello interpretativo comune a partire dalla gratuità delle pene, non conseguenti a colpe di sorta, comminate in funzione dell’obiettivo di instaurare un potere incondizionato, lo Stato moderno, appunto. (cfr. Hanna Arendt, Le origini del Totalitarismo) 5) Non condivido l’impostazione, che ritengo deterministica, che vede comunque come progresso, anche se pagato a caro prezzo, il salto dell’età moderna (ma lofu?). In realtà quel salto è stato fatto sulla pelle delle donne tutte, sulle terribili condizioni delle classi lavoratrici e a prezzo di quelle altre grandi tragedie che sono state e sono ancora il colonialismo e la tratta degli schiavi. (Legga Marcela Serrano, legga Nadine Gordimer) 6) Non sapremo mai come sarebbe stata la storia se le Amazzoni avessero vinto, se il movimento gnostico avesse avuto la meglio, se la cultura delle streghe e del Piccolo Popolo avesse prevalso: inutile, anzi, ideologico pensare di consolarci dicendo che se i vincitori hanno costruito su quei cadaveri una cultura ricca e potente, allora è così che doveva essere, nonostante le milioni di vittime che sono morte, sono state sfruttate, abbrutite, perdute. Lasciamo ai vari Göring e Hesse una simile impostazione. Non voglio offenderLa, ma provi a riflettere: affermare che il “progresso” si è affermato così, significa negare dignità e ricordo a quelle vittime in nome della pretesa che la storia comunque è andata avanti, significa giustificare quell’oppressione e quegli orrori; a parte l’hegelismo di fondo che sarebbe anche quello da discutere, io credo che non sapremo mai cosa abbiamo perso e che la perdita non può avere alcuna consolazione. Invece ritengo più corretto contestare il senso del termine “progresso”: di chi? In che cosa? Forse che la cultura occidentale è stata capace di creare più felicità, più amore, più libertà? Io non lo credo, anzi credo che la civiltà occidentale debba rimettere in discussione tutta la sua realtà a partire dalle fondamenta, legga Riane Eisler. Nessuna vera civiltà si può costruire sull’orrore: ha mai riflettuto sul perché la cultura è sempre, anche quando è allineata al potere, denuncia, opposizione, implicita o esplicita, critica dell’esistente? 7) La repressione nel Medioevo non comincia perché le popolazioni si dedicavano a tali culti; la chiesa sa che non le controlla e non le interessa (ancora) di controllarle: i contadini sono considerati massa di lavoro di livello semibestiale, inferiore. Il problema sorge nel momento in cui tali pratiche si diffondono tra le gerarchie ecclesiastiche, così come tra le classi dominanti, come Lei stesso evidenzia con l’esempio di Edoardo III. In realtà la chiesa di quel tempo non ha nessun controllo sul suo clero, all’interno del quale sono comuni stili di vita estremamente spregiudicati, dove l’erotismo è un elemento centrale (cfr. Lucrezia Borgia di Maria Bellonci). Reputo un errore credere che la repressione sia iniziata per controllare le popolazioni: l’organizzazione ecclesiastica era un istituto politico più che religioso – culturale; la diffusione di pratiche pagane al suo interno provocò l’inizio della repressione, cioè la lotta contro forme di religiosità popolare che tendevano (vedi la chiesa catara, ma anche il culto del Dio Cornuto di Margaret Murray) ad autorganizzarsi scalzando l’istituzione cristiana. L’istituzione cristiana non avrebbe avuto senso fuori dall’impero romano prima, dall’ordine feudale poi, essa ne è il risultato e la premessa: entrambi senza di essa sarebbero crollati prima o forse si sarebbero evoluti in altro ben più rapidamente. La motivazione più importante che induce a reprimere le pratiche pagane degli ecclesiastici corre lungo tutta l’epoca, dal IX al XVII secolo, come causa implicita, in ogni fase della caccia. C’è da dire che Riane Eisler, ma anche Freud, danno un senso emotivo profondo al coinvolgimento del clero, tutto, e della migliore intellettualità aristocratico- borghese nella caccia: al di là di ogni considerazione di carattere politico (vedi Bodin e il suo accanimento contro le donne), per molti era l’unico modo socialmente riconosciuto per vedere, toccare donne, per poter parlare di corpi di donne, minuziosamente frugati in ogni loro più intimo aspetto, in modo scandalosamente pornografico. Tale pratica, quel sostituire il rapporto con la donna con questo frugarne e destrutturarne il corpo e i suoi organi attraverso la parola, per sminuirne il senso e l’importanza; quel sostituire il piacere con il dolore, l’esaltazione della vita con esaltazione della morte (cfr. Eisler), la possibilità di relazione con una chiusa autosufficienza, erano iniziati, riguardo al cristianesimo delle origini, con i padri della chiesa e con Agostino, nella lunga polemica sulla nascita di Cristo, sulla sua natura e sullo statuto di Maria in quanto Madre; sono ben visibili nella polemica sul modo in cui si tramanderebbe il peccato originale, nel corso di quella lotta, politica e ideologica, contro il movimento gnostico che Lei ha raccontato. (cfr. anche Storia delle donne di Duby e Pierrot, Il Medioevo). 8) Il problema è che la paura del corpo tramandata da Socrate/Platone in poi nella cultura occidentale non è affatto razionale: Lei è pronto per affermare e diffondere una nuova cultura del corpo che non si limiti all’estetismo della contemporaneità e che reintegri la persona in se stessa? 9) Se la politica nasce con l’obiettivo di “contenere” / reprimere il potere delle donne, le quali sono talmente forti e pericolose da doverle segregare per batterne la potenza e dividerle, frammentandole al chiuso di ogni abitazione maschile, è giusto, corretto, ovvio che le donne oggi si sentano estranee a questo patto maschile contro di esse, e diffidino della politica. Perché in quel patto ne va di esse, direbbe Heidegger, poichè lo Stato, la polis, ha scritto le sue regole originarie, fondative, contro di esse. Legga Maria Zambrano, La tomba di Antigone. Le regole della convivenza per essere realmente civili vanno ricontrattate, rifondate su una base del tutto nuova: dove il potere delle donne bisogna che abbia peso determinante, e non è escluso che per un certo periodo gli uomini “ribelli”, tutti quelli della normalità di oggi, debbano essere puniti in modo severo. Bisogna guardare ai ribelli di oggi per trovare comportamenti, modelli di tipo nuovo. Lei è pronto ad accettare la guida dell’autorevolezza femminile per ricodificare le regole dell’esistenza? Quotidiana, privata, pubblica? Non volevo fare un saggio, ma mi è sembrato utile, se realmente nostro interesse convergente è la rifondazione della democrazia, aprire anche questa rete di rapporto, che spero non si riveli sterile. Con stima,
Valeria Savoca
|