Una
violazione taciuta della sacralità femminile
di Piera Serra
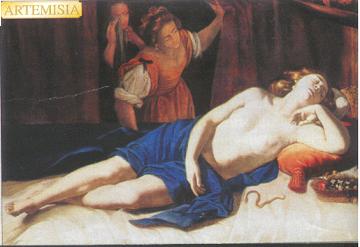
Artemisia
Gentileschi
Un paio d'anni
fa mi chiese aiuto una signora sulla sessantina, ansiosa e depressa in
seguito a una crisi coniugale innescata dalla scoperta di una grave malattia
del marito. Alla terza seduta mi volle rivelare un fatto di trent'anni
prima che "ancora le pesava": era rimasta incinta, desiderava
portare avanti la gravidanza, ma c'erano già due figlie e pochi
mezzi. "Mio marito mi chiese di abortire. All'inizio gli dissi
di no. Gli dissi che non volevo finire in balia di quelle mammane, avevo
paura. Poi, lui si informò da suo fratello, seppe di una clinica
dove si poteva fare tutto con medici e infermieri. Allora, accettai. Soffrii
molto, anche perché sono cattolica… No, non sono pentita.
Lui aveva ragione: non eravamo nelle condizioni di fare un altro figlio.
… Io ogni tanto me lo vedo, quel figlio, come se ci fosse. A volte
quando guardo le mie figlie penso a lui. Anche ieri ho detto a mio marito:
'Adesso avrebbe trent'anni'".
Avevo già ricevuto decine di testimonianze di sofferenze così
profonde associate all'interruzione di una gravidanza. Questa storia,
tuttavia, mi offrì un tassello fino allora mancante. Capii perché
al referendum si ebbe una vittoria così schiacciante pro-aborto
(quasi il 70%): le femministe avevano denunciato le atrocità sui
tavoli da cucina e gli uomini, oltre a provare pietà, avevano anche
capito che le donne si sentivano ormai in diritto di rifiutarsi di abortire,
date quelle condizioni.
Mi arrovello sulla questione dell'aborto da quando, nei cortei per l'abolizione
delle norme del codice Rocco, non sapevo dove mettermi.
Poi, giovanissima psicologa di uno dei primi consultori, fui testimone
del trauma subito dalla ginecologa alle prime esperienze e della ingenua
violenza di un'assistente sociale che rincorreva le donne titubanti per
convincerle, certa di offrire loro una liberazione.
In seguito, diventando prima psicoanalista e poi psicoterapeuta (questo
è il mio percorso, anche se può apparire un po' eccentrico),
iniziai a ricevere testimonianze dalle clienti. Non perché un'interruzione
di gravidanza possa produrre una psicopatologia - questo è acclarato:
lo conferma la letteratura specialistica - ma perché nella storia
di una ragazza o di una donna che chiede un aiuto psicologico non è
infrequente un'interruzione di gravidanza compiuta su iniziativa di altri
e vissuta come rinuncia. Basti, per fare un esempio, il caso delle donne
sottoposte a violenze fisiche da parte del partner: ho scoperto che l'aborto
può essere una forma di maltrattamento fisico, forse la più
tragica. Avviene così: l'uomo, dopo un concepimento desiderato
anche dalla donna in un momento "positivo" della relazione,
cambia atteggiamento: le fa mancare ogni sostegno, riprende i maltrattamenti,
facendo sì che ella si convinca a interrompere la gravidanza; dopodiché
inizia a lamentarsi per il "figlio" mancato talvolta rivelando
l'aborto a parenti e amici della donna. E' un copione che ho constatato
ripetersi in molti casi.
E' dal '90, con una denuncia della violazione del diritto di non abortire
su Reti, che porto queste esperienze al di fuori del segreto della stanza
di psicoterapia, ovunque mi sia concesso uno spazio per parlarne. Voce
isolata. Sordità dalle donne. Del resto, la mia non è certo
la prima denuncia in tal senso.
Il maschiocentrismo - chiamiamolo così, per isolare, dalla complessità
delle zavorre sul capo delle donne, la costrizione di carattere cognitivo
- fa sì che la legge sull'interruzione di gravidanza sia interpretata
dai ragazzi e dagli uomini come un diritto anche proprio, oltre che della
donna: l'idea che la donna in gravidanza debba assecondare la richiesta
del partner se questi ha ragione di non volere un figlio è, tragicamente,
un'idea ampiamente condivisa. E non solo tra gli uomini. E' qui che gioca
il suo peso maligno contro le donne la medicalizzazione banalizzante dell'interruzione
di gravidanza, che non è, beninteso, l'assistenza medica - da tutte
benedetta - ma la negazione delle implicazioni soggettive e dei vissuti
associati all'aborto, la sua riduzione un a un banale intervento chirurgico
al quale la donna deve avere la compiacenza di sottoporsi. L'interruzione
di gravidanza, invece, nel caso in cui la donna si sia prefigurata l'evoluzione
del concepito come figlio, è equiparabile a un'amputazione.
Non è che le donne non sappiano di avere il diritto di non abortire:
il punto è che una donna in gravidanza tende a deprimersi tanto
più se non è sostenuta moralmente (lo dimostrano gli studi
di neuropsicologia e le statistiche, al di là del mio parere sul
perché, che qui non importa): una donna depressa più probabilmente
perde autostima e potere. Allora, basta che si ritrovi sola nel desiderio
di un bambino perché possa decidere di rinunciare. E, in questo
contesto culturale, il colloquio clinico pre-aborto finisce per ridursi
a un rituale utile solo a emendare le responsabilità di tutti lasciando
il dito puntato sulla donna.
Se è certamente più frequente il caso in cui nell'interrompere
una gravidanza la sensazione di sollievo prevalga sulla sensazione di
rinuncia (come confermano i dati della letteratura psicologica), il fatto
che qualcuno - partner, madre, padre, fratello…- possa impunemente
permettersi di suggerire a una donna di interrompere la sua gravidanza
è una realtà che fa parte della condizione femminile e segna
la storia delle donne, realtà che il femminismo, con persistente
ottusità, ignora. Il processo di scelta di una donna sulla maternità
è un momento di estrema vulnerabilità. Se si ha presente
questo, di fronte a una donna in gravidanza ci si mobilita - donne e uomini
- per comunicarle il senso di rispetto per la sua sacralità, per
esprimerle sorellanza e fratellanza e, ovviamente, non ci si azzarda a
dirle che cosa dovrebbe scegliere.
Bologna,
18 marzo 2005