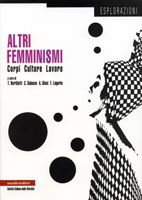|
“Altri femminismi”, pensieri e pratiche alla prova
del presente
di Anna Simone
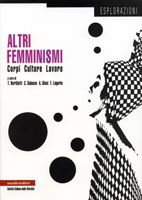
Al centro di questo volume vi sono i
sistemi di pensiero e le pratiche politiche che il femminismo ha assunto
con l’irruzione di nuovi soggetti, nell’incontro con altri movimenti e
categorie di analisi e di fronte alle emergenze del mondo contemporaneo,
dalle trasformazioni del lavoro, all’immigrazione, al fondamentalismo
islamico. Il rapporto tra il femminismo e il lesbismo e l’emergere del
soggetto trans, il confronto con l’industria del sesso, l’impatto con
l’Islam e la riflessione critica sul multiculturalismo nel mondo
post-coloniale, l’incidenza delle donne nei grandi flussi migratori.
Francia, 1838: Herculine Barbin si suicida. Nasce ermafrodito ma viene
dichiarata femmina all’anagrafe. Conduce un’infanzia da bambina
“sgraziata” rinchiusa in un istituto religioso femminile. Dopo vari
accertamenti medici e giudiziari la società del suo tempo la riconosce
come maschio e la obbliga a cambiare sesso legale e stato civile. Ma
lei/lui non regge gli obblighi della norma eterosessuale, si sente
soffocare da questa ingerenza continua sul suo corpo e si uccide. Michel
Foucault ne curerà i bellissimi diari nel 1978 in Francia. Spostiamoci
dall’altra parte del mondo.
India, 1926: Bhubanesvari Bhadouri si impicca nella casa del padre. Ma lo
fa durante le sue mestruazioni per evitare che le codificazioni
“tradizionali” della sua società potessero imputarle una gravidanza avuta
da una relazione extra-coniugale e quindi illegittima. In realtà lei si
uccide perché era un’attivista clandestina del movimento indipendentista
indiano a cui era stato chiesto di compiere un assassinio politico che
lei, emotivamente, non era in grado di sostenere. Entrambi i suicidi,
ripresi poi da Judith Butler e da Gayatri Spivak, non possono essere letti
secondo la matrice “sacrificale” delle religioni monoteiste. Herculine,
infatti, compie un “atto corporeo sovversivo” (Butler) perché lei era
anche un lui che decide di non farsi banalmente tradurre in una lei
assoluta o in un lui assoluto dalla norma eterosessuale. Bhubanesvari sa
di essere subalterna al suo leader politico, subalterna ai dispositivi
“tradizionali” della società indiana, subalterna al potere del padre. Lei
non può parlare se non attraverso un gesto corporeo ultimo e finale che
decide di compiere, appunto, durante le mestruazioni per lasciare almeno
un segno sovversivo nel mare magnum della cecità interpretativa del suo
mondo che l’avrebbe voluta solo “vittima” di un amore illegittimo.
Questo intreccio tra fatti e parole, tra realtà e produzione teorica ci
fornisce il quadro chiaro di una nuova posta in gioco politica dei
femminismi contemporanei. Herculine, Bhubanesvari, Spivak e Butler sono
qui a ribadirci che l’eccedenza, la trama intensa e appassionata che
travolge i corpi, non può mai tradursi in un unicum interpretativo. Anzi,
ci dicono con chiarezza inequivocabile che i conti non possono tornare
quando a decidere cosa sono e cosa devono dire e fare i singoli corpi è
sempre e solo l’ordine del discorso dei poteri codificati e consolidati.
Compresi quelli ideologici più all’avanguardia.
Ed è dentro questo intreccio di fatti e parole sovversive, dentro questo
contesto filosofico-pratico contemporaneo che ha tradotto l’impossibilità
della presa di parola diretta in una differenza possibile (sia pur ancora
problematica) che “prende corpo” il volume collettaneo, appena edito dalla
manifestolibri, Altri femminismi. Un prendere corpo che rovescia
qualsiasi “passione triste” della reductio ad unum dell’analisi politica,
delle esperienze militanti dei movimenti lesbo-queer, transessuali,
femministi, migranti, sex-worker, delle pratiche di contro-condotta, ma
anche del rapporto sempre più visibile che intercorre tra
femminilizzazione del lavoro, precarietà strutturale e sfruttamento del
corpo femminile attraverso la reificazione del “lavoro di cura” inteso
come nuovo mezzo di regolazione sociale ed economica. Il libro ha più
matrici di lettura proprio perché raccoglie autrici e temi che si
intersecano e, al contempo, si differenziano pur mantenendo salda
l’esperienza felice di un confronto intergenerazionale franco e
all’altezza dei grandi temi del presente: dalla biopolitica al lavoro,
dalle soggettività che cambiano segno oltrepassando le codificazioni del
sesso e dei generi alla de-vittimizzazione non acritica del lavoro
sessuale, dal postfordismo alle reti di donne migranti, dal femminismo
islamico alla lettura critica e problematica dell’infibulazione.
Il volume genera tre piste di lettura ricomposte e tramate nella bella
introduzione scritta dalle curatrici. La prima si misura esplicitamente
con le nuances del cosiddetto terzo femminismo occidentale, del lesbismo
prima e del lesbo-queer poi che ha creato non poche resistenze da parte
del cosiddetto “femminismo storico” - come se il genere potesse essere
letto sempre e solo all’interno della matrice eterosessuale e riproduttiva
- (Liana Borghi); nonché la tematizzazione dei femminismi islamici e
post-coloniali tesi a tradurre la parola negata delle “subalterne” in
presa di parola possibile e contestualizzata, posizionata e situata
all’interno di un contesto differente ma non per questo facilmente
“colonizzabile” dai valori universalistici e illuministi a cui facciamo
spesso riferimento (Ruba Salih).
Una seconda pista di lettura si misura
direttamente con il rapporto che intercorre tra l’indefinibilità di genere
dei/delle transessuali e i dispositivi di sicurezza che operano secondo i
criteri della norma eterosessuale. Belle e tragiche allo stesso tempo le
pagine di Porpora Marcasciano su l’applicazione dell’art. 1 che rendeva e
rende ancora “delinquenti abituali” i trans, soprattutto i maschi che si
travestono da donne. La terza, invece, tiene assieme il postfordismo, il
capitalismo cognitivo, la femminilizzazione del lavoro e la precarietà
(Adriana Nannicini) con il lavoro dei/delle cosiddette sex-worker.
Il saggio di Beatrice Busi evidenzia il
nesso che intercorre tra lavoro sessuale, lavoro domestico (così come
tematizzato dal gruppo delle femministe padovane negli anni ’70), lavoro
di riproduzione e femminilizzazione globalizzata del lavoro. Questi
mutamenti epocali portano Busi a sostenere la tesi del “patriarcato
diffuso” (altro che fabbrica diffusa) che spostandosi dal privato al
pubblico obbliga i nostri corpi a non essere poi tanto diversi dai corpi
delle prostitute. Sempre disponibili, sempre efficienti, sempre sensuali,
sempre accoglienti, sempre comprensive. Non è “sempre” questo che viene
chiesto a chi deve fare la cameriera per pagarsi le tasse universitarie?
Non è “sempre” questo che viene chiesto a chi muore dietro un telefono dei
call center? E non è, infine, sempre questo che viene richiesto tra le
pareti domestiche? Un contesto che ci chiede di diventare ciniche, di
agire per rimozione e sostituzione come se i corpi fossero
spersonalizzati, interscambiabili e seriali. Un contesto in cui non c’è
più tempo per amare, giocare, ridere, parlare.
Il problema del chi parla è ancora un nodo per nulla sciolto in tutti gli
ambiti della sfera pubblica. Sciogliamolo accogliendo due proposte che ci
vengono da questo libro: le soggettività si danno solo a partire
dall’irriducibilità delle loro singole esperienze; è impensabile e
riduttivo scindere le pratiche di libertà e le pratiche di contro-condotta
dalle analisi sul lavoro vivo e sul capitalismo cognitivo. Un esercizio
che né i libertari, né i marxisti hanno mai voluto praticare
congiuntamente ma che risulta, ora più che mai, urgente.
Società Italiana delle Storiche
a cura di Teresa Bertilotti, Cristina Galasso, Alessandra
Gissi, Francesca Lagorio,
Altri femminismi
autrici:
Teresa Bertilotti, Liana Borghi, Beatrice Busi, Francesca Decimo,
Cristina Galasso, Alessandra Gissi, Francesca Lagorio, Elena Laurenzi,
Porpora Marcasciano, Adriana Nannicini, Ruba Salih
manifestolibri,
2006
pp. 159, euro 15
questo articolo è apparso su il
manifesto del 27 ottobre 2006
|