Domande
all'economia globale
recensione di "Le donne e la globalizzazione"di Sara
Ongaro
di Cristina Degan
Il
libro contiene un'analisi attenta ed accurata delle problematiche di genere
legate al processo di mondializzazione dell'economia e allo sviluppo di
nuove tecnologie riproduttive. A partire dalla specificità femminile
l'autrice indaga il rapporto produzione-riproduzione, con domande che
vanno oltre la descrizione dei processi in corso e fanno emergere come
le trasformazioni del sistema economico capitalista non siano affatto
neutre.
In un ripensamento teso a chiarire quale sia il ruolo delle donne nel
nuovo contesto mondiale vengono prese le distanze anche dalle conquiste
del femminismo che risultano essere elementi di un sistema oppressivo.
La sfida consiste in una nuova concezione dell'economia, in un altro modello
di relazioni che sappia far propria la lezione d'ironia, creatività
e resistenza, presenti proprio là dove non vediamo che infelicità
ed oppressione.
La presentazione del libro è curata da Renate Siebert.
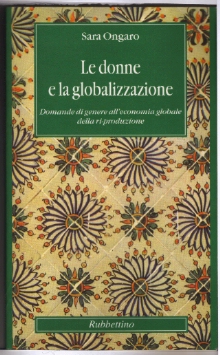
1) Ri-produzione
2) La riproduzione tecnologica: dove sono sparite le donne?
3) La femminilizzazione dentro i mutamenti del mondo
4) Produzione e riproduzione al capolinea
5) Quale invisibilità per la vita?
edizioni Rubbettino, 2001
Domande di genere all'economia globale della ri-produzione
A partire dalla decostruzione del binomio produzione-riproduzione - per
cui il termine di confronto costituito dalla fabbrica si sostituisce alla
vita - vengono poste domande di genere all'economia globale della ri-produzione,
alle altre donne, alle femministe. Innanzitutto è rovesciata la
polarità tipica della fase classica dell'industrializzazione, quella
che partiva dall'esperienza in fabbrica per dare un nome alle operazioni
del vivere quotidiano (dalla produzione si mutuava ri-produzione), seguita
da una nuova sequenza processuale per cui il corpo e/o parti del corpo,
entrano nella produzione come elementi parcellizzati e mercificati. Il
riferimento dell'analisi non è solo alle nuove schiavitù
del sesso, ma indica un contesto prostituzionale più ampio, caratteristico
della nuova industrializzazione. Si tratta di prendere in considerazione
quel piccolo extra in più che ha trasformato in prestazione contrattuale
'la differenza' femminile.
Proprio la
rinuncia alla propria specificità, in nome dell'emancipazione frutto
dell'alleanza femminismo-capitalismo, porta le donne integrate nella produzione
a liberarsi dalla riproduzione, mentre le attività riproduttive
sono convertite globalmente in produttive.
Si delineano gli elementi di un nuovo sistema oppressivo che obbliga ad
una riflessione su presunte conquiste, a rimettere sotto nuova luce termini
quali 'diritti' e 'scelte', in una prospettiva che cerca di 'disimparare'
le presunte conquiste. La passione e l'impegno disegnano una prospettiva
storico-politica e soprattutto etica che non rinuncia alla comunicazione,
ma che obbliga ad un ripensamento del modello di sviluppo capitalistico
per passare ad una produzione nutrita di relazioni e di spazi aperti anche
al contributo dell'Altro e alla forza dei sogni.
Libro da leggere con l'amore 'di' e 'per' la soggettività del genere, guardandola oltre lo specchio delle diverse generazioni ed esperienze.
Sara Ongaro è
nata a Lodi nel 1971, si è laureata in filosofia con indirizzo
antropologico a Siena e ha conseguito un master in Women and Development
a York. Vive e sogna in Sicilia dove si è trasferita per amore
del Sud e dove lavora intorno alle tematiche della globalizzazione insieme
ad altre antropologhe, riunite nella cooperativa
Daera, e al suo compagno.