Lea Melandri, Dialogo tra una femminista e un misogino
Rosaura Galbiati
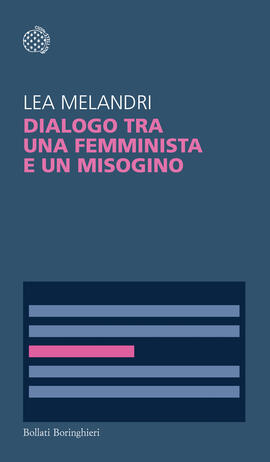
Mi sono avvicinata alle recensioni cosiddette “autorevoli” solo dopo aver finito la prima lettura del libro, la prima, perché come sempre ce n'è stata una seconda e ce ne saranno di sicuro altre. Succede con tutti i libri che mi coinvolgono e a maggior ragione con questo che, per profondità del discorso e anche una certa osticità del tema affrontato, rende necessarie più riletture. Confesso di aver fatto fatica soprattutto nelle prime pagine, e parto proprio da questa fatica, una sorta di disagio ad analizzare, non tanto e non solo il testo, quanto il mio atteggiamento, la mia postura in risposta al contenuto e alle tesi presentate.
Conosco il pensiero di Lea, in questi anni l’ho incontrato spesso in presenza a Cernusco per i nostri corsi - veniva col corpo e con la passione che la contraddistingue da sempre - e poi in varie occasioni alla Lud di Milano, alla Casa delle Donne, ma anche negli interventi sui social e, soprattutto, nei libri suoi e in quelli che in varie occasioni segnalava. L’ho seguita nelle sue riflessioni teoriche sul rapporto tra i sessi, sulle differenze tra natura-cultura, tra donna-corpo e uomo-storia, con al centro l’impianto originario nella questione madre-figlio e nella loro relazione.
Mi rendo conto benissimo di non essermi ancora addentrata nei contenuti del testo, ma non sto divagando, sto solo seguendo sia l’istinto che il filo dei pensieri, fedele al mio sentire. Non so fare diversamente.
Il linguaggio scritto rispetto a quello parlato è più impegnativo da affrontare, ma consente una maggiore riflessione, permette di ritornarci sopra e di ponderare le parole, allora mi pare che nel testo ci sia una rimasticazione - e so che la parola suona, a torto, negativa - di pensieri e tesi cardine, il dualismo corpo-mente, per esempio, che hanno occupato il ragionare di Lea per tanti anni. Del resto, lo dice lei stessa che ha pensato a lungo di scrivere questo libro e l’applicazione si sente, si sente l’intento di ritornare sugli stessi temi con insistenza, quasi un accanimento di ricerca che la fa viaggiare nel tempo, e nonostante il tempo, lungo l’affermarsi e anche il rivelarsi progressivo dei significati della cultura patriarcale e del femminismo, in questo caso sulla “Ragione su cui si era retta fino ad allora la civiltà a cui Weininger aveva dato voce”.
Basta ascoltare Lea o leggere una delle sue interviste e si capisce quali sono i nuclei su cui si aggirano il suo pensiero, il suo interesse, la sua ipotesi interpretativa della realtà espressa più volte nel tempo, e che mi pare trovino conferma in questo ultimo libro.
Attraverso le parole di Weininger, lei ascolta sia le voci più autorevoli della nostra civiltà che quelle anonime del senso comune e ci dialoga.
A dispetto di misoginia e razzismo, mette in luce la modernità del filosofo, per esempio, quando pone in discussione il binarismo di genere e quando riconosce forme intermedie tra maschile e femminile, per cui dubita di fronte alla teorizzazione di distinzioni nette. Che poi invece fa, inseguendo la polarizzazione dei due sessi e traducendoli in caratteri opposti ed estremi. A questo proposito, mi sembra contradditorio rispetto all’assunto precedente - e tuttavia reale perché anche le contraddizioni lo sono - che secondo Weininger ogni individuo sia originariamente bisessuale e la sessualità sia presente in tutti i rapporti sociali, prove queste, a detta di Lea, di “aperture sorprendenti rispetto a una normativa etero sessista e omofoba tuttora dominante”.
Più che desiderosa di porsi in antitesi - ma è scontato che lo sia - diversamente dalla citata Sibilla Aleramo, Lea privilegia l’atteggiamento dialogante e partecipativo, a me sembra di cogliere questo; quindi, il titolo è azzeccatissimo e si capisce anche l’autenticità del suo riconoscere “posso dire di aver letto e riletto ‘Sesso e carattere’ con l'emozione che […] danno soltanto le biografie delle grandi anime”. L’emozione o, meglio, un evidente amalgama emotivo-razionale.
Come punto possibile di sintonia, Lea trova che il filosofo appaia vicino al Movimento di liberazione della donna che intravedeva nell'emancipazione sociale una falsa rivoluzione, mentre altra cosa è la liberazione che deve partire dall'intimo, da ciò che le si contrappone e in qualche modo la contraddice.
Questo passaggio me ne ricorda altri dal libro di Barbara Mapelli ‘Etiche eccentriche’ dove si esprime l’importanza di un attraversamento personale, di una trasformazione dall’interno dell’individuo che può rivelare un sé costruito, segnato dai modelli imperanti. Credo che questo valga per uomini, donne e altri posizionamenti di genere, benché non nella stessa misura.
Il filosofo però appare in netto contrasto col movimento e con ciò per cui abbiamo lottato quando mette in dubbio che le donne desiderino essere persone con una loro visione e prospettiva del mondo, e in questo caso si evidenzia una distanza siderale…
Scrive Lea che le constatazioni di Weininger sulla sessualità di uomini e donne, pur nella visione patriarcale dell'epoca e nonostante possano suonare come giudizi morali, contengono delle verità incontrovertibili: le differenze di carattere tra i sessi, che riconosciamo ancora oggi come portato del passato, ma ben vive e presenti, vedono la sopravvalutazione dell'uomo e sono conseguenza “dell'esclusione delle donne dal sapere, del confinamento nella sfera domestica, nei compiti di cura, di una maggior vicinanza ai corpi e alle relazioni affettive”. Non si può che essere d’accordo. Il peso di ciò - aggiunge Lea - “impedisce alle donne anche un adeguato sviluppo della creatività intellettuale”; non so se è proprio così, certo limita e tarpa le ali al pensiero libero di avviarsi su percorsi alternativi, ma forse la creatività può nascere anche da un certo imprigionamento o confinamento e perfino dalla repressione, chissà…
Sono d’accordo con chi lo ha detto: leggere e analizzare i frammenti di ‘Sesso e carattere’ riportati nel libro provoca un doppio movimento di repulsione/ribellione da una parte e di intesa/connessione dall'altra, perché è impossibile non riconoscervi uno sguardo non solo lucido, ma anche profondo.
Mi sono chiesta più volte come il sessismo e la misoginia potessero convivere con quel tipo di intelligenza e, in fondo, di sensibilità… Verrebbe da immaginare, oltre la spiegazione che ne dà Lea, anche una sorta di trauma psichico, una frattura o un turbamento insanabile che abbia portato il filosofo al suicidio, un fatto credo impossibile da trascurare e che si inserisce per forza in tutto il discorso con una sua tragica coerenza.
Un altro aspetto che mi ha molto coinvolto e interrogato: nella filosofia di Weininger il femminile è temuto come retaggio dell’origine o radice animale dell’essere umano, ma è anche amato come somiglianza a Dio, quel divino nell'uomo, quella vittoria della spiritualità che forse il filosofo auspicava, una considerazione non semplicissima, ma molto interessante che stimola ulteriori connessioni di pensiero e interpretazioni. Lea ha la sua e intravede nel suicidio questa spiegazione: “l'annodamento, nella sua vita come nel suo pensiero, tra il sessismo, quale fondamento della Ragione classica, e la religione”. Impressiona davvero che la ricercata perfezione di santità, senso e saggezza venga riconosciuta proprio nella morte e che questa consapevolezza/convinzione venga tragicamente agita dal filosofo.
Ci sono passaggi da ‘Sesso e carattere’ che fanno sobbalzare, è quasi impossibile non sentirsi umiliata dalle definizioni che costringono le donne, la cui essenza, secondo il filosofo, "si consuma tutta nella vita sessuale, nella sfera dell'accoppiamento e della procreazione, nella relazione cioè di moglie e madre”. Queste parole, che sento violente, suscitano una reazione emotiva potente che mi riporta molto indietro a sensazioni risalenti alla prima adolescenza, al senso istintivo di ribellione a quello che vedevo intorno: all'autoritarismo di mio padre, al suo muoversi libero, e invece alla dedizione di mamma alla casa, all'assorbimento nei figli, alla dipendenza intellettuale dal marito, in definitiva a quanto l'essere madre prevaleva in modo preponderante su interessi diversi, la politica e la cultura in genere. Ricordi che toccano sia la coscienza che la memoria del corpo.
Altri concetti espressi dal filosofo e per me intollerabili: “la donna si cura di cose extra sessuali solo per l'uomo che ama o da cui vorrebbe essere amata, un interesse per tali cose in sé stesse le manca assolutamente”.
Penso che la mia sia una ribellione antica, dell’inconsapevole femminismo di allora che si rinnova a questa lettura, tuttavia, riconosco anche il ritornare a piccoli elementi di verità, per esempio - forse è una banalità - l’appassionarsi delle donne al calcio giocato dagli uomini e al far parte delle tifoserie che mi ha sempre fatto pensare a forme di compiacenza al mondo maschile.
In molti passaggi il libro mi ha fatto oscillare tra rifiuto e accoglimento di punti di vista: se la misoginia di Weininger non gli impedisce di riconoscere l'emancipazione delle donne come un'evoluzione e di condannare ogni forma di violenza, non lo distoglie dalla convinzione che a loro manchi un io morale e intellettuale e che - una pietra tombale su ogni apertura - non siano “in grado di superare la propria sessualità che le renderà sempre schiave”.
L’indignazione aumenta in modo esponenziale alla lettura di queste parole, insopportabili alla luce di tanti femminicidi: “esse si rivolgono a baciare l'uomo che le violenta”.
Non so se sono riemersa dalla rilettura del libro con una tesi lineare in testa, so che i vari punti toccati “dal misogino e dalla femminista” hanno creato squarci di consapevolezza forse disordinati ma veri, razionalmente ed emotivamente autentici.
Forse è la conclusione più importante per un lettore: il libro mi ha coinvolto. Mi ha messo a disagio e infastidito - non solo per la misoginia a tratti terribile e repellente -, ma mi ha costretto a riconoscere alcune verità e ad accoglierne altre come possibili.
Al di là di quello che ognuno trova nei libri e che può più o meno condividere, il vissuto soggettivo in lettura, come non è indipendente dai contenuti e dai pensieri con cui ci si confronta, non lo è dal ripensamento delle proprie vite, in un lavoro senza fine che dovrebbe indurre una certa consapevolezza sia rispetto alla realtà suggerita dalla propria esperienza personale, sia da ciò che si vede e interpreta nella società. Un cammino su di sé che dura una vita, aiutato dai libri, oltre i modelli e i retaggi culturali, familiari e ambientali che condizionano il vivere quotidiano.
Il grazie a Lea è obbligato e sentito."
13-10-2025
Lea Melandri, Dialogo tra una femminista e un misogino,
Bollati Boringhieri, 2025, pp.83, €12