 |
 |
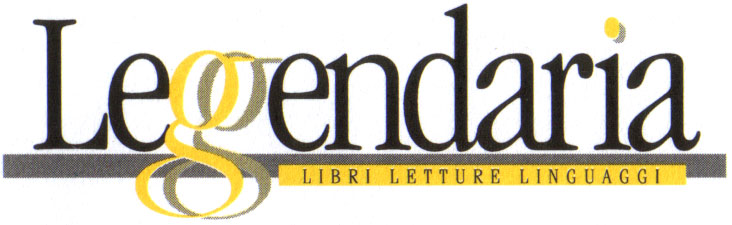 |
 |
Convegno “La rivoluzione possibile. Cura/Lavoro: piacere e responsabilità del vivere”
Milano18 febbraio 2012
Intervento introduttivo di Maria Grazia Campari su alcuni nodi problematici
I temi che affrontiamo in questo seminario fotografano una situazione complessa della quale ho percepito la problematicità nelle discussioni che hanno accompagnato e seguito la stesura del nostro libro “L’Emancipazione Malata”.
E’ noto e provato che le capacità femminili di prestare cura vengono usate dal sistema in funzione pacificatoria e sussidiaria perché garantiscono l’erogazione gratuita di ammortizzatori materiali e psicologici, consentendo cospicui risparmi sulla spesa sociale. Questi risparmi non sostengono la buona vita delle donne impossidenti: è vero il contrario.
Da qualche tempo la cura femminile si espande anche verso il corpo d’impresa per il rapporto sentimentale che molte donne sviluppano verso i propri progetti.
La conseguenza di questo slittamento è la tendenziale donazione di sé e delle proprie risorse cognitive e di socialità, al di fuori di qualsiasi compenso economico. Si tende alla gratuità (perniciosa) anche nel lavoro per il mercato.
C’è di più. Da una lavoratrice cognitiva precaria mi è stata presentata questa situazione: anche dietro la cura di sé - che impegna tempo e costa una certa fatica – spesso si nasconde la cura degli altri, in particolare dell’utilità d’impresa. La cura della pelle, delle occhiaie, il mascheramento dei sintomi di stanchezza anche dopo molte ore di attività, rispondono a una sorta di diktat sociale, ineriscono al concetto di essere produttivi. In altre parole, essere o mostrarsi in salute risponde a un parametro che suggerisce di eliminare ogni differenza dalla norma e comporta uno sforzo costante di controllo su se stessi.
Il quesito è: siamo consapevoli fino in fondo del ruolo che gioca l’attività di cura e la passione per la relazione di cura nel dare sostegno al presente (poco felice) stato delle cose?
La cura d’impresa, la cura della politica, la cura del mondo viste da alcune come esplicitazione del desiderio di buona vita, non rischiano di condurci a un colossale malinteso, a precipizio per una strada che non trova sbocco nella nostra libertà?
Per me nel desiderio di buona vita è implicito il desiderio di buon lavoro, di riuscita sociale. Come si coniugano queste aspirazioni legittime con l’attività di cura che, soprattutto per le donne italiane, è sinonimo di divisione sessista del lavoro retribuito e di inoccupazione/disoccupazione?
Dalla nostra discussione è emerso (Lea Melandri nell’Agorà del Lavoro 28 novembre 2011) che la cura dà un potere sugli altri, un potere occultato e sotterraneo, radicato nella complementarietà cui le donne non intendono rinunciare.
La complementarietà è, secondo me, il concetto chiave: non è forse l’esito di quella colonizzazione interiore di cui parla Ina Praetorius (“Penelope a Davos”)?
Questa passione per la cura, condivisa da tante, frazionata perché vissuta singolarmente, come può diventare l’auspicata forza collettiva di modificazione dell’esistente, come consente di sottrarci alla narrazione maschile dell’essere donna, come si distingue da una prassi di obbedienza?
Non va sottovalutato quello che alcune rilevano (Pausa Lavoro Via Dogana dicembre 2011): ”Il lavoro di cura può anche servire per evitare il conflitto”. E’ altro quello che ci serve:” ….un conflitto visibile, un agire politico che non si risolva in una conciliazione individuale pagata sempre a caro prezzo: con i sensi di colpa, o rinunciando al figlio, o abbassando le pretese sul lavoro” (ivi)
Attraverso quali strumenti si riesce a capitalizzare e rendere forza collettiva la consapevolezza di singole, la relazione fra poche che, secondo un certo punto di vista, è già politica, ma che, secondo me, necessita di un quid aggiuntivo (da cercare insieme nello spazio pubblico di una riflessione conflittuale e condivisa) per spostare i rapporti di forza attualmente assai sfavorevoli?
Leggo nel documento del Gruppo romano del mercoledì: ”Confidiamo nel rovesciamento che si produce nel mettere la cura al centro delle relazioni tra persone e della politica. Vorremmo scommettere sulla nuova dimensione che si apre nell’esistenza, nel farne asse della vita e della politica.”.
Mi chiedo: e il silenzio inerte degli uomini come gioca nel contesto?
O speriamo ancora in una risorsa tutta e solo femminile che modifica gli assetti della polis senza configgere, al suo solo apparire per la generosità del suo disegno?
Forse le esperienze narrate da alcune giovani donne possono fornire la traccia per un percorso assertivo, all’occorrenza conflittuale.
Due mi sono parse significative fra quelle illustrate all’Agorà del Lavoro del 30 gennaio scorso. Una giovane donna, impiegata presso una cooperativa sociale che si occupa di persone disabili, madre di due bambini, ha affrontato la prima maternità passando dal lavoro a tempo pieno al lavoro part time. In occasione della seconda maternità ha deciso di mantenere l’impegno a tempo pieno, contrattando con il partner i tempi della genitorialità in capo a ciascuno di loro, anche a prezzo di frequenti conflitti.
Un’altra giovane donna, ricercatrice in campo oncologico, dopo la maternità ha deciso di continuare a lavorare ottenendo un orario flessibile che secondo lei ha aumentato la sua attività e ha anche deciso di trovare il tempo per fare politica; ha notato che il suo sottrarsi ha consentito al partner di acquisire una sua dimensione di genitorialità di cui è molto soddisfatto.
Lei ha definito la sua esperienza come triplo “si” (a lavoro, maternità, politica). L’importante è intendersi: io sarei portata a definire questa esperienza come del doppio “no” (Picchio): no al comando patriarcale sul corpo e sul lavoro domestico, no al comando capitalista sul lavoro, un “no” che potrebbe essere favorito da una generazione di uomini e donne che sanno aprire conflitti fra loro e concluderli con mediazioni accettabili. Questa interpretazione vi sembra condivisibile o no?
Anche io considero essenziale e urgente spezzare l’ordine simbolico androcentrico, come è stato detto, ma mi chiedo come sia possibile arrivare a questo risultato se si è impegnate a tempo pieno nel prendersi cura degli esseri umani nei minimi aspetti e senza tregua, se persino si cura l’impresa (capitalistica) e la politica (squalificata) con apporto di competenze relazionali preziose, ma, forse, con effetti distorti.
Curare, nel linguaggio a me noto, significa assistere, farsi carico, non sovvertire.
Senza un conflitto radicale, un sovvertimento, non è normale che la polis resti appannaggio di uomini liberi e ben accuditi da donne socialmente irrilevanti, come nell’esperienza della democrazia ateniese?
24-02-2012