da Repubblica del 15-02-05
NOI,
l´aborto, la violenza
di Anna Bravo
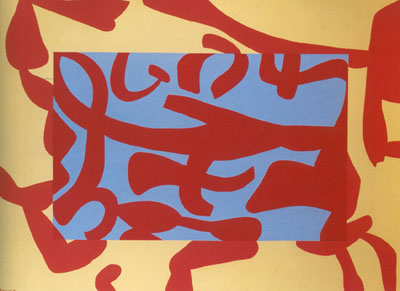
Carla Accardi
Ho scritto
un lungo articolo sugli anni Settanta, titolo: Noi
e la violenza, trent´anni per pensarci.
Ora potrei scriverne un secondo sulla violenza che mi si è rovesciata
addosso appena è uscita, sulle pagine culturali di Repubblica,
un´intervista di Simonetta Fiori che presentava
quel mio testo e il fascicolo della rivista Genesis dedicato ai
femminismi del decennio. La storia del Novecento rischia sempre polemiche,
quella della "stagione dei movimenti" è particolarmente
esposta, ma non ricordo bagarre simili. Perché, eccetto alcuni
interventi sereni, proprio di bagarre si è trattato, con il corredo
di insulti e accuse di falso, incompetenza, intimismo, revisionismo (dall´altro
ieri anche di ritrattazione). Devo essermi avventurata su un terreno minato.
Sono altrettanto indicative le modalità. Inizialmente si forza
lo scritto di Simonetta Fiori, impegnativo ma di taglio necessariamente
breve; oppure, vecchio stratagemma discorsivo, mi si fa dire qualche sciocchezza
che non ho detto, e ci si applica a dimostrare il contrario. Nel giro
di due giorni, scatta la logica del "so ben io di cosa parlo":
all´articolo di Repubblica non ci si riferisce neppure più,
basta alludere (qui vale la pena citare testualmente Elettra
Deiana, Liberazione del 6 febbraio) alle "gravissime dichiarazioni
di Anna Bravo", che dimostrerebbero come la "devastante marea
montante della restaurazione cristiana bianca occidentale che va diffondendosi
minacciosa nelle nostre contrade, a cominciare dagli Usa, (arrivi) fin
dentro le pieghe della nostra stessa storia". Ma non esageriamo!
L´aspetto
più sgradevole è che nessuna aveva letto le quaranta pagine
del mio testo. Ci vedo non solo una mancanza di rigore culturale, ma una
frivolezza che disdegna la fonte diretta, che dissuade dal dire "Preferisco
di no" persino quando sembrerebbe elementare: prima leggo, poi parlo.
Naturalmente è difficile affrontare quegli anni, perché
sono stati anche il tempo in cui uno spaccato consistente di giovani persone
ha sperimentato la presa di parola, la gioia di vivere e inventare in
comune, e noi donne anche l´autocoscienza e spazi nuovi di libertà
mentale. Per di più, "noi" è un pronome sconsigliabile,
il cui ambito di riferimento va ogni volta specificato: femminismo "storico",
delle donne radicali, del sindacato, dei partiti, dei gruppi extraparlamentari.
Per questo si usa il plurale femminismi.
Sebbene ci si possa appoggiare a riflessioni e ricerche preziose di alcune
donne (e di rari uomini), mi sembra ancora più difficile affrontare
la storia del rapporto donne/violenza in quegli anni. Alcune militanti
dell´Autonomia proponevano di creare Ronde rosa per difendersi
dalla polizia. La Libreria delle donne di Milano elaborava la tesi
dell´estraneità femminile come "scelta politica di separazione
di un pensiero femminile differente". Dentro Lotta Continua
c´era stato prima disagio, poi muro contro muro fra donne e servizi
d´ordine. La libreria delle donne di Torino teorizzava il
rifiuto "del sangue della croce, del sangue delle Rivoluzioni",
ma - Moro prigioniero - sceglieva di non schierarsi fra lo Stato e le
Br. E c´erano altre posizioni ancora, e ciascuna poteva variare
nel tempo.
A me non interessa fare la contabilità della violenza femminile,
ma lavorare sul rapporto con la distruttività di allora e sui modi
in cui è stato (o no) ripensato. Non mi interessano tanto le protagoniste
della violenza, quanto le molte donne che l´hanno incrociata, vista,
tollerata, temuta. Donne che valutano appieno la differenza fra partecipare,
essere spettatrici, contrastare, ma che condividono un´idea: da
quegli anni e dalla responsabilità di cercare una misura onesta
per raccontarli, è difficile chiamarsi del tutto fuori - a meno
di considerare i violenti e i terroristi una specie un po´ meno
umana della nostra.
Oggi dire che l´ideologia della violenza rifondatrice era cruciale
nell´orizzonte della sinistra extraparlamentare (e non solo) è
un semplice punto di partenza, e mi sembra quasi scontato aggiungere che
il contesto ha avuto sì un peso, ma che è stato usato troppo
volte per sgusciare fuori dal campo della responsabilità personale.
Eppure esistevano alternative, e mi preme appunto ripensare agli incontri
mancati, al non inevitabile effetto di cecità verso altre genealogie
che derivava da quel mito della violenza. Chi di noi, donne e uomini,
si è confrontato seriamente con i nonviolenti che digiunavano per
il riconoscimento dell´obiezione di coscienza, con la disobbedienza
dei radicali, con le opere di Thoreau, Gandhi, del nostro Capitini? E
con che distratta condiscendenza guardavamo a Mondo Beat, la rivista
dei cosiddetti capelloni, che in una campagna per la nonviolenza e contro
il militarismo denunciava l´aggressione americana in Vietnam, quella
sovietica in Ungheria, quella cinese in Tibet, riconducendole al primato
dell´ideologia sulla vita.
C´è ancora da riflettere, e lo stesso vale per l´aborto.
Trent´anni fa, credo che non potessimo pretendere da noi stesse
più di quanto stavamo variamente elaborando, dalla denuncia dello
scandalo degli aborti clandestini alla domanda radicale di Carla Lonzi:
"per il piacere di chi sto abortendo?". Avremmo meritato una
legge migliore. Che sia rimasta un´area di non detto, o non pensato,
è addirittura ovvio ? eravamo giovani, nel pieno della lotta per
la depenalizzazione, si viveva di corsa; sul possibile dolore del feto
oltre un certo stadio della gravidanza, la medicina taceva, e infatti
la parola sofferenza veniva riferita a una patologia, mai a una sensazione.
Non so se qualcuna abbia formulato la domanda che viene spontanea di fronte
a qualsiasi intervento chirurgico: "Farà male?". Sarebbe
stata una buona presa di distanza dal potere medico-scientifico, di cui
stavamo denunciando la simulazione di neutralità su altri terreni;
e un passo in più sulla strada della cura. Se si dà credito
al dolore delle donne, bisogna dar credito anche all´impegno (di
molte, di alcune?) a non duplicarlo nel feto, dunque ad aumentare l´attenzione
contraccettiva, e magari a sollevare la questione delle tecniche più
protettive per provocare, o scongiurare, l´aborto. Interrogativi
improbabili, allora - ma nessuna ha mai sostenuto che le sole domande
da porre fossero quelle ragionevoli, rispettabili, a risposta garantita.
Certo il clima non ci aiutava: fra noi (un noi ampio e misto) c´era
ben poca sensibilità alla condizione aurorale, sospesa, terminale,
o alla prossimità fra l´umano e il resto del mondo senziente.
«Vi siete mai chiesti che cos´avranno pensato le capre di
Bikini? E i gatti nelle case bombardate?», scriveva Calvino nel
'46. La nostra risposta sarebbe stata: no.
Penso anche al dopo, e al presente, ai vari medici e ricercatori laici
e pro choice che sul problema della sofferenza invitano a dare al feto
il beneficio del dubbio, perché se una cosa va fatta, bisogna scegliere
il modo meno doloroso per tutti; al fatto che in futuro sarà sempre
più difficile distinguere non tanto fra persona e non persona,
ma fra persona e persona (le manipolazioni genetiche e estetiche, il trapianto
del volto e delle mani), fra vivente e non ancora o non più vivente,
fra umano e tecnologico, fra natura e tecnonatura. La differenza, dice
Rosi Braidotti, è diventata una categoria nomade. In questi giorni,
penso ad alcune pacate inquietudini che ho avvertito.
Eppure, dire che il corpo femminile è vittima di manipolazione
cruenta e nello stesso tempo tramite di una violenza contro il feto non
equivale a equiparare aborto e terrorismo. E´ nominare un dilemma,
angosciante, forse esposto a strumentalizzazioni; il rischio è
che non si trovi mai il momento adatto per enunciare temi controversi.
Sì, il rapporto con la violenza è un punto delicato, ma
non necessariamente un punto debole, tanto più che, come problema
storico-teorico e come dannazione del presente, molte donne se ne sono
fatte carico. Perché non discuterne pacificamente? Tutto quel che
ho scritto qui si trova nel testo ignoto.