Nei territori dell'interiorità
di Nicoletta Buonapace
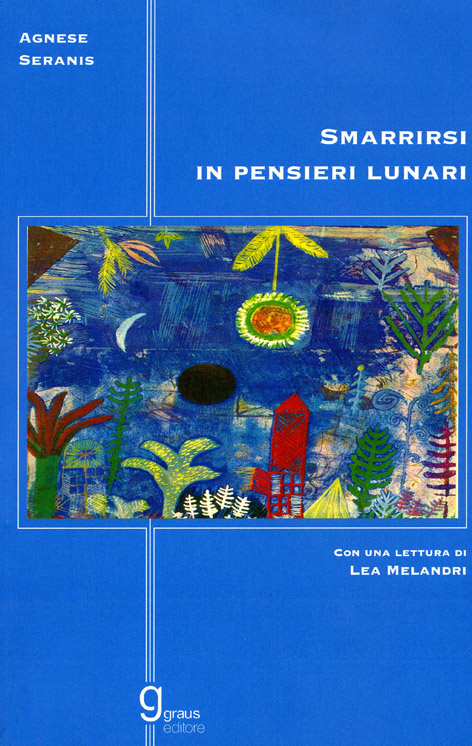
Non è una lettura facile quella del libro di Agnese. Ci chiede di inoltrarci con lei nei territori di un’interiorità che osa un’esplorazione di sé ai limiti del dicibile. E, in effetti, quel che è straordinario è proprio questo suo esser riuscita a dare parola a un sentire che mantiene e disvela l’incandescenza di ciò che normalmente è sepolto nei labirinti della coscienza, che eccede l’universo di senso creato dagli uomini e da cui è escluso uno sguardo femminile, che qui s’interroga fino allo sfinimento e che drammaticamente oltre a sperimentare la rottura di schemi profondamente introiettati, si affaccia sul vuoto che quell’universo ha lasciato.
Agnese mostra attraverso un linguaggio spesso visionario, una lingua talvolta “gridata”, le maschere e gli inganni di un sapere, di una cultura, di un sistema normativo che indica cosa sia la “normalità”, la “femminilità”, e che uno sguardo maschile ha costruito come neutro e universale, segnato invece necessariamente dalla sua parzialità.
Alice, la protagonista, si scontra violentemente con le immagini e un ruolo di donna cui si è vista consegnata da un altro in un processo che inizia fin dall’infanzia e che per stratificazioni giunge da una parte a formare un senso d’identità precario, dall’altra a condizionarla fino a compromettere la sua integrità.
Il formarsi d’un’identità consapevole di sé è quanto di più complesso esista nel divenire di chiunque, ma per una donna è un processo più difficile, più doloroso, contraddittorio, dal momento che deve confrontarsi con un “femminile” che di fatto è costruito astrattamente e che non la riflette o che entra in contrasto con quella che è la concretezza di un’esperienza di sé, la percezione e la costruzione della propria storia.
Alice ubbidisce alla necessità prepotente di ri-raccontarsi, per riappropriarsi di una vita che ha vissuto, sentito più spesso da “spettatrice” che da protagonista, una vita che ha guardato con gli occhi di un altro e lo fa per andare a trovare la sua propria voce, la sua originalità.
Ci sono pensieri, comportamenti, un senso comune, che passano attraverso sentimenti, affetti, messaggi spesso inconsci, sepolti nell’infanzia e che per questo diventano così forti e fonte di disorientamento nel momento in cui si scontrano con una verità su di sé che emerge in modo prepotente.
Uno degli episodi più toccanti e drammatici del libro è quello in cui Alice, che ricorda la sua infanzia, racconta un gioco di guerra, e non è un caso che sia un gioco di guerra, tra bambini, nel quale diviene, con le altre bambine, alla fine della battaglia, vittima dei compagni “vincitori”, gioco crudele che evoca, pensando al mondo degli adulti e delle loro guerre, quelle vere, il rituale tristemente noto dello stupro dei soldati sulle donne e che rivela quanto sia profondo e originario l’intreccio di amore/odio nella relazione degli uomini con le donne.
“Io non so perché non abbiamo mai smesso di giocare con loro a fare le prigioniere.”, confessa Alice e qui si apre un’altra pagina dolorosa sulla trasmissione in linea femminile di questo continuare ad essere vittime, del non poter che “giocare alla casa”, alla moglie, alla madre.
“Ecco io non so che cosa avremmo potuto fare perché tutte le donne grandi che vedevamo non facevano nient’altro se non cucire e mettere in ordine la casa e le contadine davano da mangiare ai polli e ai conigli e era tutto lì e il prete del paese ci parlava sempre delle sante soprattutto di Maria Goretti e della Madonna e sembrava che noi fossimo proprio diverse dai bambini e non potevamo fare che quello: il gioco della casa...”.
Una diversità dunque percepita, ma senza voce, prigioniera di un universo chiuso, finalizzata non tanto all’espressione della propria unicità, singolarità, ma a un ruolo, appiattita in un dover essere “uguali” a un modello di donna.
C’è lo scarto infine, ma è uno scarto che apre necessariamente un conflitto: “ …non sono mai diventata una donna come intendono loro o come mi ha detto un uomo una volta: Non riesci ad essere femminile. Ma non capisco bene che cosa voglia dire femminile ed è inutile che lo chieda perché nessuno lo sa.”
E’ commovente questo “nessuno lo sa”, perché dice tutto lo smarrimento, tutta la solitudine in cui si trova una donna nel momento in cui rinuncia ad alimentare, a conservare, tutte quelle immagini di femminilità che le sono state messe addosso come una maschera da portare e che sono diventate carne, sangue, pelle.
Si apre il conflitto dunque ed è un conflitto violento, che riguarda la relazione con l’uomo, quella con sé e la rigidità dei ruoli fissati per l’uno e l’altra, mi vien da dire, fin dall’inizio della storia, con i racconti e i miti che alla base di una civiltà pongono un rito di violenza e rapina come il ratto delle Sabine, per esempio, o l’assoluzione per il figlio colpevole dell’uccisione della madre, in quello di Oreste.
Come fosse stato necessario per gli uomini, che su questo hanno fondato la società e la famiglia patriarcali, separarsi dalla madre, dalla casa, dalla dimensione della sentimentalità, attraverso un atto di violenza, deputando poi la custodia di ciò che per sé hanno escluso, alla donna.
Agnese ci mostra la possibilità, fosse anche estrema, attraverso una lucida follia che nella parola riesce a dirsi, d’un divenire soggetto per colei che decide di svincolarsi da ciò che le è stato costruito addosso.
S’inventa una lingua senza pause, che fluisce ininterrotta dalla coscienza, per eccedere il sistema entro cui è immessa, un sistema in cui affetti e norme agiscono sulle singolarità, sulle sessualità, irrigidendole al fine di conservare un ordine basato sulla cancellazione della donna, sull’eterosessualità obbligatoria, sull’esclusione della diversità, sul dominio del più debole da parte del più forte.
Questo sguardo eccentrico fa resistenza all’identificazione con i modelli di femminilità imposti e resistenza a un pensiero binario costruito per opposizioni: passivo/attivo, natura/cultura, maschile/femminile, ragione/emozione e così via.
Lasciare che s’incrini tale sistema di pensiero, interrogarlo, significa però precipitare in un labirinto nel quale è arduo orientarsi, trovare un senso che ancora, in qualche modo, deve trovare espressione compiuta.
“Ogni giorno non era anche questa percezione di silenzio di me di impossibilità a svelarmi a me stessa che mi dava questa angoscia: sentirsi svincolata sentirsi impedita da interferenze da false immagini buttate su di me dagli altri …”.
E infatti non è possibile, per Alice fino alla fine sostare nell’interrogazione, nella domanda, nella dimensione del negativo.
Ha bisogno di fare appello a un universo altro, a un’idea di femminile potente, una Grande Madre, un pensiero lunare che “illumina gli abissi dell’immenso cosmo”, pensiero che alimenta un sentimento di universalità, di comunione con la Vita e che non a caso emerge nel racconto della gravidanza, della maternità.
Pensiero che immagina il proprio corpo come “un alternarsi di stagioni l’espandersi dell’universo l’esplosione di una supernova il big bang”.
Un corpo che anche nell’immaginario femminile diventa dunque onnipotente, depositario di un potere altro, legato a un divino materno, in continuità con la vita del cosmo, l’eternità, un tutto non più segnato dal limite e dalla mancanza che è iscritta nel semplice fatto di averlo, un corpo, e di essere finiti/e, vulnerabili, mortali.
Alla fine forse è proprio solo un’appartenenza a sé, alla fine d’un viaggio che ha toccato limiti estremi, quella che rimane e che dà misura alla possibilità che con un coraggioso atto di verità si è data una donna nella ricerca di una fedeltà a se stessa:
“leggera libera camminerò”
“dalle mie mani quand’esse solo a sé apparterranno
quand’esse profondamente si conosceranno”.
Agnese Seranis,
Smarrirsi in pensieri
lunari
Graus Editore, Napoli, 2007
altre letture di
Lea Melandri
Daniela Pastor
Silvia Treves
Articolo pubblicato in Leggendaria, n.67, febb. 2008