|
Femminismo, ma quali colpe?
Analisi
del saggio di Anna Bravo sugli anni Settanta
di Paola Di Cori
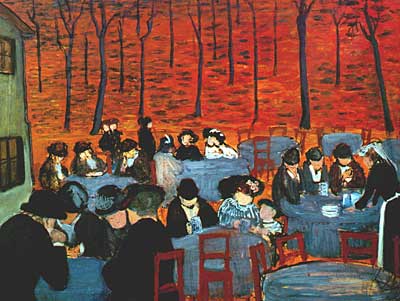
Marianne von Werefkin
E'poco elegante, quando si legge un testo da recensire, cominciare a
elencarne subito i difetti e le mancanze. Chiedo quindi scusa se è proprio
questa, ahimè, la tentazione che ho avuto leggendo l'ultimo numero di
Genesis, rivista della Società Italiana delle Storiche, curato da Anna
Bravo e Giovanna Fiume, e dedicato agli anni Settanta.
Nei giorni scorsi una intervista su Repubblica di Simonetta Fiori a Bravo
- autrice del saggio principale di Genesis - Noi e la violenza. Trent'anni
per pensarci - ha suscitato molti commenti. Miriam Mafai ha efficacemente
replicato, e su Liberazione sono intervenute, con argomentazioni assai
condivisibili, Lea Melandri e Maria Schiavo.
Il punto che ha provocato le reazioni più vivaci è quello che affronta il
legame tra femminismo, violenza e aborto; in particolare la scarsa
sensibilità che le donne avrebbero allora manifestato nei confronti del
dolore del feto e la loro acquiescenza nei confronti della diffusa
violenza presente nei gruppi politici della sinistra extra-parlamentare.
Dati i limiti dello spazio a disposizione, anziché inserirmi nel dibattito
suscitato dall'intervista, preferisco commentare brevemente il fascicolo
di Genesis, la cui parte monografica, oltre a quello di Bravo, è composta
da altri tre contributi, rispettivamente di Paola Gaiotti De Biase
(Cattoliche e cattolici di fronte all'aborto), di Elda Guerra
(Femminismo/femminismi), di Emmanuel Betta e Enrica Cappussotti (L'epica
dei movimenti tra storia e memoria).
Anticipo subito che chi volesse cercare analisi stimolanti sulle donne e
su quel periodo è destinata a rimanere profondamente delusa. La sensazione
generale di chi legge è quella di una cura distratta, scarsamente
interessata a presentare il decennio e a interrogarsi sulla storia del
femminismo, ma tesa a sottolineare soprattutto una tesi - la rimozione del
tema violenza sviluppato da Bravo nel suo saggio. I quattro articoli della
parte monografica appaiono slegati l'uno dall'altro, compagni occasionali
di un viaggio dove ciascuno siede per conto proprio in un vagone separato.
L'introduzione conferma questa impressione: poche pagine, di cui più della
metà dedicate a sottolineare l'urgenza di affrontare il tema violenza; e
per il resto, una rassegna un po' provinciale di qualche testo di
interpretazione storica; nessuna ipotesi teorica sugli strumenti
concettuali da utilizzare nel fare storia del femminismo e degli anni '70;
nessuna indicazione né curiosità nei confronti degli importanti recenti
sviluppi delle scienze storiche e sociali su questi problemi in contesti
non italiani (mi riferisco in particolare alla Francia, tralasciando
l'immenso patrimonio di ricerche esistente in lingua inglese, ma anche
spagnola e tedesca, di cui non c'è quasi traccia).
Nonostante le intenzioni espresse nell'introduzione, l'idea del decennio
che rimane dopo la lettura di Genesis, è assai poco problematica. Ma ben
più grave, (e il contributo pur importante di Elda Guerra non può supplire
alle carenze di fondo) è la scarsa valorizzazione dell'esperienza
femminista, qualcosa che conviene esaminare soprattutto per le sue
ambiguità, omissioni, rimozioni, "mancanza di immaginazione". Molto meno
interessante, per le curatrici, è costruire una memoria in positivo del
femminismo, affermare alcune acquisizioni, indicare gli immensi contributi
di esperienze e di conoscenze, proporre obiettivi di ricerca avanzata,
costruire nuove forme di relazionarsi con le generazioni più giovani.
Nel loro insieme questi saggi inducono alla malinconia (del resto è quasi
ovvio, se si privilegiano temi come le sofferenze fetali, la violenza e la
morte); comunicano incertezze e scarso entusiasmo per il proprio oggetto
di studio, che rimane statico e poco definito. La storia del femminismo
sembra sempre qualcosa ancora da fare, ancora da immaginare, ancora da
cominciare a impostare: tale mancanza viene attribuita in massima parte al
mai risolto nodo della violenza e dell'aborto. Oppresse dal senso di colpa
per siffatta rimozione, in Italia le donne non sono state in grado di
costruire una prospettiva storica scientificamente solida sul femminismo.
Chissà come mai ci sono invece riuscite nel resto del mondo, per esempio
nelle vicine Francia e Germania (le pubblicazioni recenti sulla storia del
femminismo in questi due paesi riempiono ormai qualche
scaffale, anche se Genesis le ignora!) dove la tradizione ugonotta e
luterana deve pure aver acuito il peso della colpa per le brutalità
inferte al feto e l'ambiguo silenzio di fronte alla ferocia del
terrorismo. Ma forse oltralpe le donne sono ancora più insensibili delle
italiane.
Non posso entrare in dettaglio nel merito dell'articolo di Bravo, che è
lungo 40 pagine e occupa un terzo circa della parte monografica.
Piuttosto, sono rimasta assai sorpresa per il tipo di ricostruzione
proposta, da militante interna a Lotta Continua, un gruppo dove i temi
della violenza erano all'ordine del giorno, come noto; ma soprattutto dove
l'opportunità di denunciare collusioni e ambiguità non fu del tutto eluso,
in particolare tra la fine del '77 e i due anni successivi. Di questo
dibattito («lo sfondo è soprattutto torinese») tra aderenti a Lotta
Continua, comprese molte donne, non c'è traccia nel testo di Bravo
nonostante i principali interventi - a cominciare da quello di Andrea
Casalegno che lo sollevò in una drammatica intervista all'indomani
dell'attentato al padre nel novembre '77 - siano stati tutti pubblicati;
cfr. Sulla violenza. Politica e
terrorismo, Savelli, 1978; La violenza e la politica, Savelli, 1979;
Vivere con il terrorismo, di Luigi Manconi, Mondadori, 1980. E poi, se è
proprio questo che interessa sviluppare, perché non prendere in
considerazione una ricerca assai seria e approfondita come quella di
Isabelle Sommier (La violence politique et son deuil. L'aprés 68 en France
et en Italie, Rennes, 1998)?
Inoltre, come mai Bravo non ha tenuto conto dei contributi delle
femministe? Gli scritti di Ida Farè (Mara e le altre, Feltrinelli, 1977),
il numero speciale di Differenze sulla politica, alcuni saggi di Luisa Passerini, qualcuno anche mio sulla soggettività in storia e sulle donne
armate? Non è un po' troppo intimista la chiave prescelta? («quello che
segue è un abbozzo fondato sui pochi testi in cui la questione della
violenza affiora, su dialoghi con amiche di allora e di oggi, sulla mia
memoria autobiografica…»). E a che scopo preferire l'intimismo a una
indagine più solida, più documentata, o a un'articolazione teorica meno
improvvisata, entro la quale recuperare almeno alcuni testi fondanti della
prima metà del '900 (Benjamin sulla violenza, Simone Weil sulla guerra
civile spagnola, tra altri), per inserirle all'interno di una lettura
critica attuale su guerra e violenza, così come si sta facendo da più
parti?
Gli anni '70 sono stati ben altro, e il femminismo un progetto di
trasformazione entusiasmante e vitale; e quindi anche contraddittorio,
irrisolto e inafferrabile. Non certo riducibile al quadro mortifero
presentato da Genesis.
articolo apparso su
Liberazione
dell' 8 febbraio 2005
|