Margherita Hack, una scienziata libera
di Liliana Moro

È una delle menti più brillanti della comunità scientifica italiana che ha segnato la scienza astrofisica, dando un valido contributo al processo di rinnovamento dell’astronomia italiana. Prima donna a dirigere un osservatorio astronomico in Italia, ha dato un valido contributo alla ricerca per lo studio e la classificazione spettrale di molte categorie di stelle ed ha sempre svolto un’importante attività di divulgazione
Margherita Hack nacque a Firenze 12 giugno 1922. Il padre, di religione protestante, lavorava
come contabile e la madre, cattolica, era diplomata all’Accademia di belle arti.
Entrambi insoddisfatti delle loro religioni e chiese, aderirono alle dottrine teosofiche, intrecciando rapporti con un ambiente che sarebbe stato loro di sostegno nei momenti più difficili.
Quando il padre perse il lavoro, per motivi politici (non essere iscritto al partito fascista e simpatizzare per il sindacato), la madre fece la miniaturista alla Galleria d’arte degli Uffizi e la vendita delle sue opere ai turisti costituì un’entrata importante per la famiglia.
Vegetariani convinti, trasmisero questa cultura alla figlia, che non ha mai mangiato carne ed ha anche coltivato fin da piccola grandi amicizie a “quattro zampe”. Amicizie basate su una grande attenzione alla vita: in Qualcosa di inaspettato (Laterza, 2004) racconta dei gatti e dei cani più amati e ricorda con precisione il primo incontro e la data della morte, dimostrando una rara attenzione ai non-umani.
Non corrisponde all’immagine dello scienziato astratto, fuori dal mondo. Anche la passione per la politica forse rientra in questo lato del suo carattere: l’attenzione alle persone e a chi soffre, e l’impossibilità di tollerare le ingiustizie. E’ sempre stata attenta al contesto sociale e politico ma da quando è in pensione, si è impegnata più attivamente tanto che nel 1993 è stata eletta consigliera comunale a Trieste. Ma l’esperienza di consigliera comunale l’ha delusa, le piace di più lavorare nelle associazioni di base. In “Qualcosa di inaspettato” narra che ancor prima di assumere la carica era stata presa dal “... senso di inutilità che avrei provato a vivere la politica lontana dalle idee e dalle utopie che la dovrebbero animare. Ho sempre aspirato a una politica che vada incontro a chi è più debole, a chi ha bisogno; una politica che migliori la società...”
Narra spesso di aver in qualche modo “scoperto” il fascismo da ragazza negli anni del liceo, quando, per effetto delle leggi razziali, vide sparire all’improvviso compagni e professori ebrei.
Frequentava il prestigioso liceo classico “Galileo Galilei” di Firenze, giocava a pallacanestro e fece atletica, anche negli anni dell’Università ottenendo ottimi risultati a livello nazionale: nel 1942 fu prima classificata nel salto in alto ai Littoriali di Como.
A undici anni Margherita conobbe tra i compagni di giochi, Aldo de Rosa, un ragazzo di due anni maggiore, che sarebbe diventato in seguito suo marito. Ritrovò Aldo dieci anni dopo, nel 1943, all’Università di Firenze, dove frequentavano l’una la Facoltà di Fisica e l’altro quella di Lettere. Si sposarono l’anno successivo e sono ancora uniti. La collaborazione tra loro rappresenta un ottimo esempio di quanto possa essere fecondo il dialogo tra discipline: cosa che contravviene il pregiudizio classico della contrapposizione tra cultura umanistica e cultura scientifica. Un pregiudizio tanto più forte in Italia, dove l’intero sistema scolastico è segnato da questa separazione dove la prevalenza è data alla cultura umanistica, ancora sulle tracce del pensiero di Benedetto Croce, come giustamente sottolinea Hack. nel suo recente lavoro Libera scienza in libero stato (Rizzoli, 2010)
Mi permetto di spendere una parola in più su questo tema perché io stessa ho vissuto la ricchezza di questo dialogo e come possa portare a risultati del tutto inattesi lavorando da storica con Sara Sesti, matematica, alla ricerca sulle scienziate, un progetto che ha portato alla pubblicazione di Donne di scienza e poi alle varie edizioni di Scienziate nel tempo, fino all'ultima di quest'anno .
Aldo seppe dare veste letteraria alle ricerche di Margherita e la spinse verso la divulgazione: una costante importante almeno quanto l’indagine scientificamente avanzata. La divulgazione è una scelta consapevolmente fatta per la convinzione che il grande pubblico debba conoscere la scienza per poter apprezzare gli investimenti che la collettività fa in ricerca, quando li fa, ovviamente.
“Spesso la gente mi chiede per quale motivo si debbano spendere tanti soldi per mandare un telescopio nello spazio, invece di utilizzare quel denaro per la ricerca di una cura contro il cancro. ... [ritengo] utile ricordare a tutti quanto dobbiamo al progresso, attraverso risultati e conquiste che spesso si danno per scontati” (Qualcosa di inaspettato, Laterza, 2004, p.150-151)
L’attenzione a un modo nuovo di fare ricerca inizia fin dalla tesi, che fu in astrofisica. Margherita si laureò a guerra finita, nel 1945, con una ricerca sulle cefeidi, una classe di stelle variabili. Il lavoro fu condotto presso l’Osservatorio astronomico di Arcetri, dove la Hack iniziò ad occuparsi di spettroscopia stellare, che sarebbe diventato il suo principale campo di ricerca.
Quando Margherite parla di sé, refrattaria ad ogni idealizzazione, spiega la scelta per l’astronomia come avvenuta quasi per caso, perché altre specializzazioni della facoltà di fisica erano per lei improponibili. E’ ben chiaro, però, che voleva fare un lavoro di ricerca sul campo non di consultazione di testi, scelta per nulla scontata allora.
La passione per la scienza si è sempre coniugata con l’attenzione alle persone: nei vari laboratori dove ha lavorato si è preoccupata di instaurare un clima di collaborazione “democratica” e di dare spazio ai giovani. Sostiene che le più importanti scoperte si fanno entro i 40 anni, è un dato innegabile della storia della scienza: Einstein aveva 25 anni quando formulò la sua teoria della relatività.
Importanti le esperienze all’estero che le hanno permesso di respirare un’aria diversa da quella asfittica degli osservatori italiani. Accompagnata dal marito, trascorse vari periodi fuori d'Italia : collaborò con l’Università di Berkeley (California), l’Institute for Advanced Study di Princeton (New Jersey) dove scrisse un libro con Otto Struve, l’Institut d’Astrophysique di Parigi, gli Osservatori di Utrecht e Groningen in Olanda, le Università di Città del Messico e di Ankara.
Ha svecchiato l’astronomia italiana che giaceva in una situazione di seria arretratezza provocata dalle scelte del regime fascista, si consideri che la rivista più prestigiosa di astronomia “Memorie della Società astronomica italiana” era scritta in italiano con abstract in latino. Da notare che in precedenza, alla fine dell’800, l’Astronomia italiana era all’avanguardia tanto che era stata fondata la prima rivista di astrofisica della storia. (da Angelo Secchi, Giuseppe Piazzi e Giovanni Schiaparelli).
Margherita Hack ha fondato nel 1978 la rivista L’Astronomia.
Nel 1959 scrisse con Giorgio Abetti, Le nebulose e gli universi-isole, un libro così all’avanguardia che venne tradotto anche in inglese.
La situazione è completamente cambiata all’Osservatorio astronomico di Trieste dal 1964, quando ne assunse la direzione. La sua gestione, durata fino al 1987, rivitalizzò una istituzione che era l’ultima in Italia sia per numero di dipendenti e di ricercatori che per strumentazione scientifica, portandola a rinomanza internazionale. Tanto che vi giungono giovani ricercatori dall’estero, invertendo la tendenza generale della fuga dei cervelli.
L’enorme sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, che Margherita Hack aveva promosso in università, pose il problema di creare un Istituto di Astronomia. Fu istituito nel 1980 e sostituito nel 1985 da un Dipartimento di Astronomia, che la scienziata diresse fino al 1990. Dalla sua nascita, nel 1982, ha inoltre curato una stretta collaborazione anche con la sezione astrofisica della Scuola internazionale superiore di studi avanzati : Sissa.
La carriera scientifica di Margherita Hack si è intrecciata a quella degli astronomi più importanti dell’ultimo secolo. Le sue ricerche hanno toccato diversi settori: ha studiato le atmosfere delle stelle e gli effetti osservabili dell’evoluzione stellare e ha dato un importante contributo alla ricerca per lo studio e la classificazione spettrale delle stelle da 0 a F. I suoi lavori più importanti vertono sulle stelle in rapida rotazione, chiamate stelle ad emissione B, che emettono grandi quantità di materiale e a volte formano anelli o inviluppi stellari, e sulle stelle ad inviluppo esteso. Ha contribuito in particolare allo studio delle stelle di tipo Be, caratterizzate da uno spettro continuo solcato di righe scure. Le sue recenti ricerche includono la spettroscopia, nel visibile e nell’ultravioletto, dei sistemi a stelle binarie, nei quali le due componenti sono così vicine da interagire, e delle stelle simbiotiche.
Libera scienza in libero stato
Rizzoli, 2010
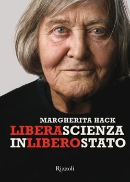
Margherita Hack in questo libro conferma la serietà del suo impegno culturale:
affronta problemi di grande attualità, come la questione della ricerca, dell’università, della scuola e più in generale della cultura oggi in Italia.
Questione come sappiamo spinosa che ha visto anche negli anni scorsi e vede a tutt’oggi un movimento di migliaia di giovani, donne e uomini, cittadini che hanno dovuto scendere in piazza per esprimere il loro dissenso alla recenti iniziative governative sulla scuola e sulla ricerca.
Hack affronta la questione a modo suo, cioè davvero da scienziata:
inizia dai dati, dalle informazioni di base sulla scolarità, sull’efficienza della scuola (misurata da indagini europee PISA), sulla storia dell’università italiana a partire dal dopoguerra, sulla riforma Gelmini.
E fornisce la sua preziosa testimonianza sull’astronomia italiana, anche qui ne fa la storia, una storia narrata dall’interno e con cognizione di causa.
Riconosce il valore della preparazione scientifica in Italia, tanto è vero che molti laureati italiani ottengono ottime posizioni all’estero e molti ricercatori italiani vincono concorsi x progetti internazionali.
Rispetto all’attuale fuga di cervelli Margherita Hack sostiene che il rapporto con l’estero in sé non è affatto un problema, purché poi si ritorni a riportare le cose interessanti che si sono viste altrove, proprio quello che ora non succede più in Italia.
In Astronomia la dimensione internazionale è imprescindibile, se non altro per la necessità di usare in modo coordinato gli osservatori distribuiti sul pianeta in località opportune per l’osservazione del cielo. Dovrebbe essere così per tutte le discipline, oggi però in Italia la presenza di ricercatori stranieri è ostacolata dalle leggi sull’immigrazione, che ostacolano la permanenza di tutti gli extracomunitari.
Libera scienza in libero stato è anche un testo politico: inizia con la citazione del discorso di Calamandrei del 1950 pronunciato al congresso dell’ “Associazione per la difesa della scuola nazionale”.
“La scuola, organo centrale della democrazia, perché serve a risolvere il problema della formazione della classe dirigente [...] Nel nostro pensiero di democrazia, la classe dirigente deve essere aperta e sempre rinnovata dall’afflusso verso l’alto degli elementi migliori di tutte le classi, di tutte le categorie. [...] A questo deve servire la democrazia, permettere ad ogni uomo degno di avere la sua parte di sole e di dignità. Ma questo può farlo soltanto la scuola, la quale è il complemento necessario del suffragio universale”
E’ un punto particolarmente interessante per le donne, che certo ormai hanno accesso all'istruzione, non subiscono più le discriminazioni del passato, quando era loro vietata l’iscrizione alle università e anche ai licei. Ora le ragazze sono addirittura più scolarizzate dei loro coetanei maschi. Ma la classe dirigente è ancora esclusivamente maschile, c’è quello che è stato definito un soffitto di cristallo, perché invisibile ma solidissimo, che impedisce alle donne di salire in alto, ai vertici delle istituzioni economiche, politiche, culturali.
E anche di ricevere compensi uguali agli uomini.
In una ricerca pubblicata quest’anno due docenti dell’Università di Pavia, Carolina Castagnetti (Economia dei mercati finanziari) e Luisa Rosti (Economia del lavoro), hanno analizzato i dati Istat sull’inserimento professionale dei laureati del 2004 tre anni dopo il conseguimento del titolo di studio. Si nota l’esistenza di un differenziale retributivo lordo tra donne e uomini (che lavorano come dipendenti a tempo pieno) pari all’11%.
E questo senza affrontare il tema della maggior precarietà del lavoro femminile.
Il problema dell’istruzione apre al problema della cultura presente nella società, e qui Margherita Hack scrive delle pagine molto significative sul declino culturale dell’Italia di oggi e in particolare sul problema della diffidenza nei confronti della cultura scientifica. Una diffidenza che si basa anche sulla contrapposizione tra cultura umanistica e cultura scientifica. Un pregiudizio tanto più forte in Italia, (aggiungo io) dove il sistema scolastico, soprattuto alle superiori, è ancora segnato da questa separazione che sottende una prevalenza della cultura umanistica. Si rimane sulle tracce del pensiero di Benedetto Croce e Giovanni Gentile, quel ministro dell’istruzione che nel 1925 diede un poderoso sostegno al regime fascista - consolidatosi proprio in quell'anno con l'assassinio di Giacomo Matteotti - promulgando la riforma da cui è ancora marchiata la nostra scuola.
Margherita Hack analizza le varie situazioni in cui la diffidenza verso la scienza ha giocato un ruolo nelle recenti vicende politiche italiane: dalla legge 40 al problema del testamento biologico, ai tentativi di smantellare la legge 194. Situazioni in cui l’iniziativa ecclesiastica è stata molto forte.
Della scienza in Italia non è possibile parlare se non a partire dalle figure di Giordano Bruno e di Galileo, cosa che appunto Hach fa in Libera scienza in libero stato e questo inizio illumina la natura dell’indagine scientifica italiana, condizionata dal pesante intervento del potere ecclesistico.
Allo stesso modo del rapporto tra donne e scienza non è possibile parlare se non a partire dalla figura di Ipazia. E questo inizio illumina la natura dell’indagine scientifica delle donne, osteggiate prima e dimenticate poi.
Abbiamo già detto della preclusione all’istruzione fin verso la fine dell’800 in Europa e in America, diciamo del pensiero diffuso che considera la mente femminile poco adatta agli studi scientifici, astratti e rigorosi. Convinzione condivisa naturalmente anche dalle donne, tanto che ancora oggi le scelte di studio e di carriera sono molto connotate sessualmente.
La cosa imprevedibile è che nonostante tutto ciò sono esistiti ed esistono pregevoli esempi di donne che hanno lavorato in campo scientifico con limpidezza, libertà e profondità di ricerca. Come la stessa Hack.
Questo discorso non è fatto per perorare una causa, per avanzare rivendicazioni a favore di una categoria svantaggiata, le donne non sono panda da proteggere. Il problema è che i pregiudizi, le esclusioni e le forti marcature di genere che predeterminano le inclinazioni degli individui di entrambi i sessi recano grave danno alla società nel suo insieme, che così facendo non può avvalersi di capacità che restano latenti, inespresse. Si creano insoddisfazione individuale da un lato e povertà collettiva dall’altro.
13-11-2010